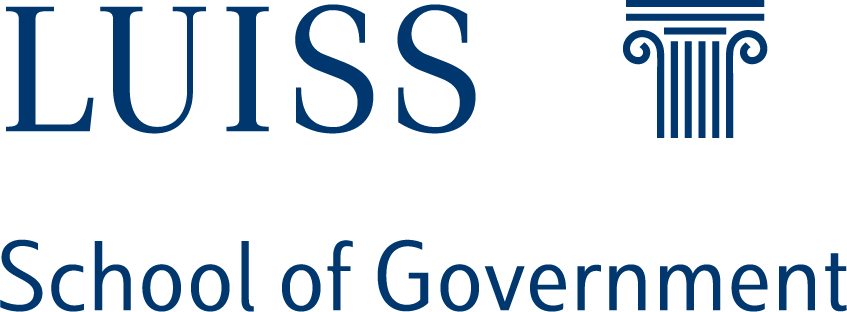11 settembre, il mondo vent’anni dopo. Mics a colloquio con tre giornalisti-testimoni

di Fabio Massoli
Vent’anni. Cosa, anzi quanti sono vent’anni? Un’eternità oppure uno rapido schiocco di dita, tutto dipende da quale prospettiva si voglia leggere la storia. Nei libri del liceo, ad esempio, venti anni trovano spazio in poche parole, forse righe, correndo di secolo in secolo: da Romolo e Remo alla caduta dell’Impero in trenta pagine, la guerra dei 100 anni in un capitolo, il viaggio di Colombo in un paragrafo. Vent’anni però possono essere anche lunghissimi, indefiniti, interminabili. Questione di prospettiva. Alzate lo sguardo, guardatevi intorno e pensate a quante cose siano cambiate negli ultimi due decenni. L’egemonia di internet, la rivoluzione digitale, l’era dei social network. Chiedete ad un bambino di oggi cosa sia un floppy disk e questo vi guarderà perplesso prima di tornare a dedicarsi alla live Twitch che sta seguendo sul suo smartphone. Vent’anni possono essere così lunghi da contenere una nuova moneta unica, due crisi economiche, tre papi, il primo presidente di colore degli Stati Uniti, dodici governi italiani, una pandemia e tanto altro. Se il bambino di prima chiedesse a un bambino di vent’anni fa di dirgli cosa siano Facebook, Youtube, l’iPhone o le smart tv collegate ad internet tramite Wi-Fi, egli contraccambierebbe lo stesso sguardo perplesso prima di tornare a giocare a Snake sul suo Nokia 3310. La società dei consumi ha cambiato le nostre abitudini così tanto in così poco tempo, come mai era successo prima dalla scoperta del fuoco. Eppure ogni volta che il calendario si avvicina a quel giorno di settembre sembra che tutto inizi a rallentare fino a fermarsi, un velo di nebbia scenda sui nostri occhi e la mente – almeno per chi vent’anni fa era abbastanza grande da ricordare – torni inesorabile a riproporre immagini che si ripresentano con una nitidezza inimmaginata. È impressionante cosa può fare il cervello umano: non ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri sera, ma potremmo descrivere con estrema dovizia di particolari quel pomeriggio. D’altronde, ogni volta che se ne torna a parlare, il ritornello finisce per essere sempre lo stesso: “Io ricordo perfettamente dov’ero e cosa stavo facendo l’11 settembre 2001. E tu?”.
Non c’è esagerazione nel dire che quanto avvenne a New York e Washington, DC tra le 8:46 e le 10:28 segnò un inevitabile spartiacque tra un prima e un dopo. I voli American Airlines 11 e 175 che si schiantarono sulle Torri Gemelle, il volo American Airlines 77 che devastò un’ala del Pentagono, il volo United Airlines 93 che, solo grazie all’eroico intervento dei passeggeri a bordo, si disintegrò in un campo della Pennsylvania anziché raggiungere chissà cosa, forse Capitol Hill o la Casa Bianca: l’attacco sferrato dall’organizzazione terroristica Al-Qaeda al cuore dell’Occidente ha incrinato la retta della storia, lasciando una ferita mai rimarginata nel petto di chi – in ogni angolo della Terra – visse quei momenti. È un po’ come la cicatrice di Frodo Baggins, nei racconti di J.R.R. Tolkien, che si riapre più dolorosa che mai ad ogni anniversario di quella ferita. Se andate a New York e visitate il 9/11 Memorial, l’area dove sorgevano le torri ed oggi mausoleo a cielo aperto, vivrete un’esperienza quasi surreale: il rumore di downtown Manhattan che scompare – come in segno di rispetto – lasciando spazio al suono del silenzio dell’acqua che cade nelle voragini nere delle due vasche, il museo memoriale sotterraneo dal quale esci dopo quattro ore di visita con un senso di sgomento difficile da scrollarsi di dosso, con una parte di te rimasta nella sala dove è vietato parlare e nella quale tremila volti ti scrutano non lasciando modo di nasconderti. Tremila vite, storie, talenti, passati e futuri strappati al modo in nome di una guerra ideologica insensata.
L’anniversario di quella giornata, nella quale il diavolo si palesò agli occhi del mondo, è ogni anno toccante, ma questa volta sicuramente lo è di più: la nostra mente è così complessa che gli anniversari a cifra tonda hanno sempre un impatto diverso rispetto agli altri. E poi in vent’anni ci sono due generazioni: chi oggi è un adolescente non ricorda quel giorno o forse non era addirittura nato. Per questo, nonostante l’inevitabile sensazione di angoscia e sgomento che ne scaturisce, è importante ricordare e provare a tirare le somme su come il mondo sia cambiato dal 2001 ad oggi. Nelle prossime righe si è provato a fare questo esercizio con il prezioso contributo di chi, per lavoro, raccontò in prima linea quei giorni così drammatici: Giulio Borrelli – corrispondente dagli Stati Uniti per il TG1, Marco Bardazzi – corrispondente da New York per l’Agenzia ANSA, e Don Dahler – giornalista per la ABC News. A loro va il ringraziamento per il tempo concesso e la preziosa testimonianza fornita.
Undici settembre 2001 – Undici settembre 2021. Vent’anni dopo qual è il suo ricordo personale di quei momenti? Le immagini che le tornano in mente si stanno man mano affievolendo o ancora oggi sono nitide e ben impresse?
GIULIO BORRELLI: Quel martedì ero nel mio studio che sistemavo degli appunti in vista di un imminente viaggio in Cina al seguito del presidente Bush quando vidi in televisione il primo aereo schiantarsi. Il tempo di chiamare la redazione e di recarmi negli uffici di corrispondenza RAI di New York e, appena arrivato, vidi il secondo attacco che fece fugare definitivamente ogni dubbio sulla natura di quella tragedia. Iniziò così una diretta lunga quaranta giorni. Scendendo in auto nella zona dove sorgevano le torri ricordo il fumo che avvolgeva qualunque angolo di downtown e le persone che risalivano Manhattan: cittadini, turisti, brokers di Wall Street completamente ricoperti di polvere. Ricordo di aver raccolto subito la testimonianza di un italiano, Lucio Caputo, riuscito a salvarsi in maniera rocambolesca fuggendo appena in tempo dalla seconda torre nella quale si trovavano i suoi uffici. Ciò che però mi colpì maggiormente dal vivo fu l’odore acre di carne umana bruciata, di ferro incandescente e di ogni qualsivoglia materiale che era andato disintegrato. La sensazione che ebbi fu che quel giorno l’America perse per un momento il controllo dell’intera situazione: aeroporti, ponti, tutta Manhattan per alcune ore fu off-limits. La tensione in quelle prime ore era altissima per il rischio che altri attentatori fossero nascosti in città e in effetti questa tesi fu in qualche modo confermata qualche anno dopo, quando venne diffuso un video dello schianto da un’angolazione diversa – sotto Brooklyn – totalmente diversa da quella in possesso delle televisioni.
MARCO BARDAZZI: I grandi eventi lasciano su di noi una traccia del tipo “dov’eri? cosa stavi facendo?”: dal mio punto di vista è impossibile non ricordare l’11 settembre 2001, avendolo vissuto in prima linea vivendo a New York con tutta la mia famiglia. Da giornalista quella fu una delle rare occasioni in cui ci si ritrova proprio malgrado non soltanto semplice spettatore ma protagonista vero e proprio. Di quel martedì ricordo ogni minuto, così come ricordo i giorni prima e i mesi successivi. Mi spostai dall’ONU, dove mi trovavo, e arrivai al World Trade Center dopo il crollo della seconda torre: di quello scenario apocalittico ancora oggi ho il ricordo sia dell’odore nauseabondo che ti attanagliava ma anche dell’incredibile quantità di carta sparsa in giro; camminavo su contratti, documenti riservati, email di gente che stava prenotando le vacanze ai Caraibi. Tutto ciò che prima era in verticale ora stava sparpagliato in orizzontale per downtown. Mi tornano alla mente immagini di luce surreale per via della polvere e non dimenticherò mai le immagini degli scoiattoli di Battery Park ricoperti di polvere dopo ore e ore, una polvere composta da tante cose tra cui corpi umani andati disintegrati. Sì, una polvere fatta di persone che ti restava addosso per settimane.
DON DAHLER: Ne ho davvero tanti. Era una giornata bellissima, il cielo blu e quella gradevole temperatura tipica di settembre. Le finestre del mio appartamento erano aperte. Ricordo di aver allungato la mano verso la caffettiera per versare la mia seconda tazza di caffè mattutina quando il rumore ha scosso l’intero edificio: sembrava un ruggito e un grido allo stesso tempo. Non potevo ancora immaginare che quello sarebbe stato il momento in cui le vite di tutti noi sarebbero cambiate. Mi affacciai alla finestra appena in tempo per vedere un’enorme ondata di fiamme divampare dal buco frastagliato di una delle due torri: pensai doveva essere un missile, cos’altro avrebbe potuto provocare così tanti danni? Mi sbagliavo, era molto più orribile di così. Ancora, ricordo la gigantesca palla di detriti che rotolò giù su Church St. con il crollo della prima torre e la gente, interamente ricoperta di polvere, che camminava in giro per downtown Manhattan come degli zombie storditi. Ricordo l’odore di morte, nauseabondo, che sembrò durare per settimane. Ricordo gli occhi, vuoti, supplichevoli, delle persone che giravano con le foto dei loro cari e familiari scomparsi, chiedendo a chiunque se per caso li avesse visti. Infine, ricordo un buco nel cielo: lì un tempo sorgevano due splendidi grattacieli.
Come reagì New York City nelle ore e nei giorni successivi?
BORRELLI: La prima reazione che lessi negli occhi della gente fu di grande stupore, sgomento e paura perché mai l’America era stata attaccata all’interno dei suoi confini. Allo stesso tempo però ricordo grande pudore e l’intenzione di mostrare, seppur con difficoltà, dignità: ad esempio venne fatto il massimo sforzo per non mostrare i corpi delle vittime intorno al luogo degli attacchi così come le immagini delle persone gettatesi dalle torri. Ancora, lo stesso Caputo mi raccontò di aver incrociato sulle rampe di scale un gruppo di pompieri che stavano risalendo la torre e che gli fecero spazio per consentirgli di scendere più rapidamente: proprio i vigili del fuoco quel giorno pagarono un prezzo enorme in termini di vite. Ricordo i tanti lumini accesi in ogni angolo delle strade, il suono delle chitarre e dei sassofoni che riempivano l’aria: credo quello sia stato il segnale, insieme a tanti altri, della volontà di dare una risposta nazionale e patriottica nonché l’immagine di un Paese che non voleva soccombere. Nei giorni successivi si formarono più volte e spontaneamente cordoni di persone che applaudivano incessantemente i soccorritori e i volontari che lavoravano senza sosta sopra i resti delle Twin Towers: fu davvero toccante lo sforzo che venne fatto nello scavare, anche a mani nude, per giorni alla ricerca di eventuali superstiti.
BARDAZZI: Personalmente rimasi molto colpito dal fatto che già il giorno dopo gli attentati Union Square divenne il punto di confluenza di tantissimi giovani e artisti che iniziarono a realizzare memoriali, a suonare musica, a cantare: era come se la città stesse ripartendo da lì. Oltre a questo, ciò che ancora ricordo molto nitidamente sono le migliaia di volantini “missing” tenute in mano dai familiari che vagavano per le strade in cerca di notizie o anche solo di qualcuno che fosse in grado di raccontare loro gli ultimi minuti di vita di un proprio caro. Insieme alla prima reazione emotiva dei newyorkesi, credo che il giorno in cui l’America ripartì veramente fu una settimana dopo – con l’apertura di Wall Street. Mi recai allo Stock Exchange insieme agli operatori di borsa e il terrore di tutti era che alla riapertura, dal punto di vista finanziario, sarebbe stato un patatrac con conseguenze drammatiche per gli Stati Uniti e tutto l’Occidente: la borsa in effetti crollò, ma non come si temeva e anche il vedere i dipendenti recarsi a lavoro tra le macerie avvolti nelle bandiere a stelle e strisce fu molto significativo. Penso che, in un momento di grandissima tensione, l’aver evitato un crack finanziario immediatamente dopo gli attentati fu in qualche modo un momento di ripartenza.
DAHLER: Beh, inizialmente la reazione di tutti fu di assoluto shock: era semplicemente impossibile riuscire a comprendere un simile atto di odio, oltre ovviamente all’entità dei danni causati – soprattutto per ciò che riguardava il drammatico numero delle vittime. Dopo questo iniziale stato di disperazione la città decise stoicamente di non lasciarsi sopraffare dall’impotenza: iniziarono quindi immediatamente le ricerche dei sopravvissuti insieme a tantissime altre manifestazioni di solidarietà che fecero capire al mondo intero e a chi aveva pianificato quegli attacchi come quanto accaduto non avrebbe spezzato gli animi della città e della nazione intera.
La risposta della politica all’11 settembre 2001 fu immediata e forte: un mese più tardi iniziarono i primi bombardamenti in Afghanistan. Vent’anni dopo come valuta quella reazione?
BORRELLI: Le reazioni della politica furono molteplici, tra tutte quelle del sindaco di New York Rudolph Giuliani e del presidente George W. Bush Jr.: il primo chiese ai turisti e ai cittadini degli Stati Uniti di tornare a visitare fin da subito la città e di non lasciarla sola; il secondo, dopo alcune affermazioni avventate delle prime ore, si recò sulle rovine di Ground Zero dove dichiarò praticamente con un megafono in mano guerra ai terroristi e l’inizio delle ostilità. Le decisioni politiche prese furono a mio avviso frutto di una situazione straordinaria che si era venuta a creare: in Italia fui tra i primi a parlare di atto di guerra – e per questo venni anche ripreso da alcuni commentatori, salvo poi vedere lo stesso Bush parlare di atto di guerra e del fatto che avrebbero risposto con la coercizione. Si discusse sull’accentramento di molti poteri, ma in stato di belligeranza è comprensibile che i poteri vengano in qualche modo accorpati nella figura del comandante in capo. Le decisioni che vennero prese quelle settimane cambiarono di fatto il modo di vivere degli americani: se prima di allora ad esempio si poteva girare liberamente e senza troppi vincoli, dopo l’11 settembre vennero adottate misure restrittive circa la privacy e le modalità di identificazione del tutto eccezionali.
BARDAZZI: Oggi, visto com’è andata a finire ad agosto scorso, diventa difficile dire che quella in Afghanistan fosse una guerra che andava fatta ed è ovviamente sconcertante l’esito maturato dopo vent’anni di missione. Penso però che quella reazione nel 2001 – non tanto la guerra bensì l’operazione di antiterrorismo internazionale – fosse un qualcosa di inevitabile e giustificato; se parliamo di due anni più tardi e dell’invasione dell’Iraq si possono sollevare tutti i dubbi possibili, ma l’Afghanistan credo sia stato politicamente inevitabile da parte di Bush. Come sempre ci sono dinamiche che restano nascoste e chi prende la scelta finale, in questo caso Biden, poi si assume tutte le responsabilità. Secondo me dovremmo invece interrogarci sul disastro che l’amministrazione Clinton fece negli anni ’90 in Afghanistan e nella lotta al terrorismo: Al Qaeda è prosperata e i talebani sono diventati quello che sono perché quell’amministrazione lì se ne disinteressò e perché, quando iniziò ad interessarsene, scoppiò il sexgate che portò Clinton a pensare ad altro: paradossalmente possiamo quasi dire che è Monica Lewinsky ad averci distratto da Osama bin Laden e questo è naturalmente drammatico. Ciò che intendo è che quello che avvenne nel 2001 possiamo capirlo solo se guardiamo al decennio precedente. Bush, nonostante in campagna elettorale si fosse mostrato disinteressato alle questioni estere, comprese immediatamente – grazie anche al suo staff – la chiave di lettura della vicenda ed ebbe il merito di recarsi subito a New York a parlare alla gente nel celebre episodio del megafono e del “We can’t hear you! I can hear you!”: lì è stato bravo a riunire il Paese soltanto un anno dopo le elezioni dalle quali era emersa un’America politicamente divisa a metà. Inoltre va detto che la gestione politica fu inevitabilmente eccezionale: pensare al Patrioct Act e a tutto ciò che ne è conseguito è un esempio. Il tema della libertà personale e della privacy fu rivisto completamente, ma anche questo in qualche modo rientra nella logica del fatto che ci si trovava in un momento in cui occorreva rispondere in una maniera assolutamente spropositata rispetto alla norma. Ci sono stati eccessi e abusi che non vanno assolutamente ignorati – Guantanamo ne è l’esempio lampante e più drammatico – ma se una cosa va riconosciuta a Bush è l’essere riuscito a non rendere l’intero mondo musulmano il nemico numero uno, cosa che invece l’amministrazione Trump ad ogni attacco dell’ISIS tendeva a rimarcare.
DAHLER: In quanto giornalista normalmente evito di rilasciare dichiarazioni politiche. Quello che posso dire però è che credo fermamente come allora ci siano state alcune persone in carica che abbiano approfittato della situazione e dell’umore della nazione per promuovere le proprie ambizioni personali e il desiderio di potere. L’espansione delle operazioni di intelligence e, infine, delle azioni militari alle quali abbiamo assistito in tutti questi anni non sarebbero mai avvenute senza l’11 settembre 2001.
Ci furono delle falle clamorose a livello di sicurezza che portarono alla tragedia? C’è chi sostiene che il caos delle elezioni nel 2000 fece distogliere gli occhi da alcuni seri indizi che lasciavano presagire a un grave pericolo imminente.
BORRELLI: L’11 settembre 2001 è il fallimento dell’intelligence americana, senza alcun dubbio, ma non penso che ciò sia legato in qualche modo alla lunga querelle delle elezioni precedenti. Fu un fallimento dei servizi segreti perché tante informazioni a disposizione non vennero valutate correttamente. Riporto come esempio gli addestramenti che i dirottatori fecero in America e che lasciavano destare moltissimi sospetti: uno di questi individui, nel Minnesota, fu addirittura denunciato all’FBI dal suo istruttore senza però che la segnalazione avesse poi un seguito. Un numero preciso di persone si iscrisse in America a dei corsi aeronautici interessandosi soltanto della manovra di volo e non di quelle di decollo ed atterraggio: il fatto che tutto questo non sia stato preso in considerazione dalle autorità competenti è pazzesco. Se non è questo un fallimento dell’intelligence, un evento del tutto imprevisto nonostante le numerose avvisaglie, cos’altro può esserlo? Tanto è vero che successivamente agli attacchi vennero adottate delle misure di ristrutturazione degli apparati di intelligence, con una sorta di accentramento di tutte le agenzie, a testimonianza dell’assoluta impreparazione precedente.
BARDAZZI: Assolutamente, ci furono falle clamorose e il livello di disattenzione fu totale. Di nuovo, è già dagli anni ’90 che vennero commessi i primi errori: lo smantellamento dell’apparato d’intelligence una volta conclusa la guerra fredda e il credere che non ci fossero state più situazioni d’emergenza internazionale fu uno di questi. Si è di fatto perso un decennio di valore dell’intelligence. Alla CIA credo ci fossero forse un paio di persone in grado di comprendere la lingua dei soggetti che poi hanno architettato l’attentato. L’intero apparato americano addetto a questo tipo di controlli era totalmente ignaro di ciò che stava accadendo perché completamente focalizzato su altro: una situazione che rimanda a quanto stiamo vivendo oggi con il cyber-terrorismo, per il quale mi auguro non si ricada nello stesso errore. Vent’anni dopo è sorprendente pensare alla facilità con il quale gli autori della strage siano riusciti a compiere quegli atti, ma dobbiamo considerare appunto che nel 2001 il livello di controllo era molto più basso e che ci si trovava difronte a una totale disattenzione e impreparazione dell’intelligence: non che non ci fossero segnali di emergenza e pericolo, il punto è che vennero costantemente ignorati e sottovalutati. Errore imperdonabile.
DAHLER: In questi vent’anni sono stati scritti molti libri sulla questione. Personalmente credo sia innegabile che prima degli attentati ci siano stati numerosi segnali di allarme dei quali varie agenzie di intelligence erano a conoscenza ma che hanno invece trascurato di condividere, anche per un senso di competizione con le loro agenzie consorelle. Per esempio Osama bin Laden aveva quasi lasciato intendere palesemente che stava pianificando una grande operazione terroristica e, ancora, com’è possibile che nessuno sia stato avvisato di un gruppo di uomini che pagavano in contanti per lezioni di volo senza alcun interesse ad imparare come decollare ed atterrare? Questi sono solo alcuni esempi lampanti di indizi ai quali non è stata data l’attenzione dovuta dalle agenzie cui spettava controllare.
Questa domanda, in questi giorni, assume un valore molto particolare: la guerra al terrorismo lanciata dal presidente Bush si conclude con il caos in Afghanistan e i talebani di nuovo al potere. Certo, bin Laden è stato giustiziato e Al-Qaeda smantellata, ma alla luce di quanto avvenuto a fine agosto che giudizio va dato alla missione?
BORRELLI: Vent’anni dopo tutta l’esperienza viene inevitabilmente ripensata e rivista con occhi diversi a causa di quanto successo nelle fasi di ritiro delle truppe americane. L’intenzione di Bush nei giorni immediatamente successivi all’attentato non era certamente quella di esportare la democrazia bensì quella della rappresaglia. Per poter fare un’analisi il più oggettiva possibile va fatto lo sforzo di guardare le cose senza l’emotività del singolo momento: allora l’America non aveva altra scelta se non fare ciò che ha fatto. La presa di coscienza che il fanatismo islamico fosse qualcosa di sottovalutato e molto serio, nonché il fatto che la vita dei cittadini e la sicurezza del Paese fosse in pericolo, ha costretto gli americani ad intraprendere l’azione militare. Certo, si può discutere ovviamente sulle modalità e le scelte fatte durante la stessa guerra: a mio avviso un errore è stato non concentrarsi sul concetto di nation building, in quanto una volta terminata la missione iniziale non si è stati successivamente in grado di realizzare una struttura statuale in grado di reggere alla situazione. Pensi, se qualcuno non avesse imbracciato le armi contro il fascismo e il nazismo oggi i seguaci di Hitler dominerebbero il mondo. La guerra va evitata ove possibile, ci vogliono le mediazioni e la diplomazia, ma in certi momenti essa è purtroppo inevitabile. Nel 2001 lasciare campo libero a quelle organizzazioni avrebbe voluto dire commettere un grave errore. Com’è stata condotta questa guerra è invece un tema tutto da discutere: corruzione, sperperio di denaro e mala organizzazione hanno portato al veloce ritorno dei talebani di questi giorni.
BARDAZZI: Senza dubbio è stata una grandissima sorpresa assistere a questa fase conclusiva della missione e al ritorno dei talebani. Il presidente Biden è sempre stato un grande esperto di politica estera e il primo sostenitore di un ritiro delle truppe fin dai tempi di Obama, però una volta scelta tale strategia ci si sarebbe aspettati un’organizzazione dell’execution ovviamente diversa. È comprensibilissimo rivendicare le mancanze dell’amministrazione precedente e gli accordi presi da Trump a Doha, ma le responsabilità di quella attuale sono innegabili. Che bilancio fare dunque dopo vent’anni? Sicuramente all’epoca l’operazione era quella giusta da fare, il problema è che c’è stata poi approssimazione nel pensare che una volta vinta la parte militare fosse finito tutto e non ci fosse invece da costruire una nuova nazione. Biden è stato nettissimo nel dire che la loro operazione era di antiterrorismo e non di nation building, però questo apre a interrogativi enormi: dobbiamo pensare alla seconda guerra mondiale, al Piano Marshall che ha salvato l’Europa. Vent’anni fa l’errore fondamentale è stato quello ideologico commesso da Bush nel pensare che la democrazia potesse essere esportata con le armi e una volta fatti cadere i cattivi andarsene mentre lì fioriva da sola la democrazia: il mondo non è così e non lo è in particolare quello arabo. Mi auguro che questo non diventi l’inizio di un totale disinteresse americano per questa realtà: se lasci un vuoto, qualcun altro lo riempirà e se questo verrà riempito da Cina e Russia allora si apriranno tutta una nuova serie di interrogativi.
DAHLER: Ho trascorso in totale più di un anno in Afghanistan, Paese all’interno del quale ho effettuato molti viaggi per coprire diverse operazioni di guerra, sia con le truppe americane sia con i mujaheddin locali. Seppur non riesca ad immaginare che gli Stati Uniti siano più disposti a mantenere i soldati lì e a spendere milioni di dollari per sostenere il governo afghano a tempo indeterminato, ciò che è successo in queste ultime settimane è stato a dir poco uno shock. Ho conosciuto numerosi soldati afghani e non posso credere che ci sia stata così poca o addirittura nessuna resistenza all’avanzata dei talebani. Onestamente non so cosa significhi tutto questo, se semplicemente non avevano la volontà di mantenere intatta la loro democrazia o se culturalmente gli afghani sono un popolo così abituato ad essere governato da uomini forti che una vera democrazia è soltanto una fragile importazione dall’Occidente. Come al solito però quello che è certo è che le persone che soffrono e soffriranno di più per questo tipo di caos sono e saranno uomini, donne e bambini che vorrebbero cercare semplicemente di vivere in pace la propria vita.
In quei minuti, giorni e settimane i media si sono ritrovati a giocare un ruolo-chiave: un attentato terroristico raccontato in diretta. In che modo televisioni e giornali hanno svolto il loro compito di narrazione dell’evento?
BORRELLI: Fu un’informazione – soprattutto nelle settimane post 11 settembre – cosiddetta “embedded”, legata agli stati maggiori e a chi dirigeva la guerra, poiché in quel momento era necessario diffondere un determinato clima nell’opinione pubblica: si trattò dunque di un’informazione piuttosto autocensurata. Possiamo dire che il giornalismo d’inchiesta che ha reso celebre la stampa americana nel corso della storia, il celeberrimo “quarto potere”, nei primi mesi dopo gli attentati più che un cane da guardia (watchdog) sembrò essere un cagnolino da salotto: esso assecondò senza porsi domande tutte le informazioni che gli giungevano dai piani alti della politica e dell’esercito. Bisognerà attendere la fase delle operazioni in Iraq e delle prime immagini di Guantanamo per vedere finalmente l’informazione tornare a verificare le informazioni fornitegli: nonostante ciò molte cose vennero lo stesso ignorate o non approfondite. Dal punto di vista dei singoli giornalisti le dinamiche dell’attentato fecero sì che gli stessi si ritrovarono a vivere la vicenda non in maniera distaccata bensì in prima persona. In definitiva la stampa, come l’opinione pubblica, si unì intorno alla figura del presidente degli Stati Uniti e alle decisioni da egli prese: la definirei perciò un’informazione patriottica.
BARDAZZI: All’epoca dei fatti l’informazione era veramente il quarto potere: CNN, New York Times e le grandi testate detenevano ancora il monopolio dell’informazione, cosa che oggi purtroppo non è più: dico purtroppo perché non mi sembra un mondo migliore quello in cui l’informazione è totalmente frammentata ed affidata ad una pluralità di fonti che rende molto difficile certificare l’affidabilità delle notizie. Il ruolo svolto dalle testate americane allora fu caratterizzato da grande responsabilità e competenza: ad esempio, se la politica americana era totalmente distratta da quelle che erano le questioni afghane, il NYT della mattina dell’11 settembre – l’ultima testimonianza di un’era da lì in poi mai più esistita – riportava una lunghissima analisi sulle questioni afghane, ad indicare l’attenzione che il giornalismo stava avendo verso una crisi internazionale che forse nemmeno la CIA aveva. Fu poi straordinaria la capacità di racconto delle televisioni in quei mesi, penso alla lucidità dell’inviato della CNN Alessio Vinci nel descriverci dal vivo l’Afghanistan sotto bombardamento. È stata inoltre incredibile la narrazione dei giornali riguardo l’11 settembre 2001 e le mille storie che compongono quel giorno: è lì che è nata l’eccezionale volontà di esplorare e ricostruire ognuna delle tremila vite spezzate, le quali poi altro non sono che tremila storie diverse in grado di diventare storia comune grazie all’attività di giornalismo. Sono quindi tanti i punti a favore di un giornalismo che, ricordiamo, all’epoca lavorava con una gamma di mezzi a disposizione decisamente minore rispetto a quelli di oggi. Oltre a tutto ciò va però purtroppo sottolineato come ci sia stato un momento di cedimento e di assuefazione da parte dei giornali alla pressione politica, secondo me più che sulla questione afghana, sull’Iraq: lì si è abbassata la soglia di guardia e molti giornalisti si sono lasciati convincere troppo facilmente dalle fonti politiche e di intelligence, facendo venir meno quel senso critico che avrebbe reso evidente l’inesistenza dei fondamenti sui quali l’amministrazione poggiava il senso dell’intervento iracheno.
DAHLER: Riguardo a quel giorno posso soltanto parlare della mia esperienza, dal momento che ovviamente non ho avuto modo di guardare nessun’altra diretta televisiva. Ricordo soltanto che mi sono concentrato sull’essere assolutamente calmo, preciso e attento, senza lasciarmi andare ad alcun dramma o esagerazione. Quando ho visto le persone gettarsi giù dagli edifici in fiamme ho riflettuto se avessi dovuto raccontarlo in diretta, decidendo infine di non farlo dato che non potevo confermare con certezza che quelli fossero corpi di persone che si stavano lanciando nel vuoto. Devo ammettere che sono stato molto indeciso, ma alla fine credo che quella presa sia stata la scelta più giusta: era un fatto così orribile che non volevo parlarne, causare indicibili sofferenze a chi aveva ancora dei cari negli edifici per poi magari scoprire di essermi sbagliato. Per quanto riguarda i media in generale, è stata sicuramente una sfida eccezionale per tutti i mezzi di informazione e tutte le testate giornalistiche coprire in diretta i momenti degli attacchi e i giorni seguenti. Dobbiamo tenere presente che tutto ciò avvenne prima dell’avvento degli smartphone e dei sistemi di alimentazione basati su cellulare utilizzati dalla maggior parte delle reti e delle stazioni odierne che non si basano su camion satellitari per trasmettere da postazioni remote. Ma al di là di quelli che potevano essere problemi tecnici, è importante sottolineare che tanti giornalisti stavano lavorando sotto shock e attanagliati dal dolore: molti di noi conoscevano persone morte quel giorno ed è stato straziante intervistare i familiari, i sopravvissuti e i soccorritori giorno dopo giorno.
Alcuni sociologi sostengono che con l’assassinio del presidente Kennedy sia nata la teoria del complotto. Gli attentati al World Trade Center e al Pentagono hanno dato nuova linfa a questo filone di pensiero? È a Ground Zero che vengono gettati alcuni dei semi che porteranno al proliferare del fenomeno delle fake news?
BORRELLI: A mio avviso la proliferazione delle teorie del complotto e delle fake news è dovuto ai social, in grado di enfatizzare alla massima potenza qualsiasi ipotesi e affermazione. Vorrei però leggere la questione sulle cospirazioni nate riguardo l’11 settembre da un’altra angolazione, tornando ai giorni successivi agli attacchi, quando ancora i social non c’erano: in alcune parti del mondo fondamentalista arabo c’era una grande euforia – raccolta in diverse testimonianze – e quei fatti vennero celebrati con brindisi e festeggiamenti. Per loro l’aver colpito in una maniera così sorprendente l’America era una manifestazione della forza e dell’intelligenza del mondo arabo. Tutto questo accadde quel giorno e in quelli successivi. Nel momento in cui però l’America si armò e diede vita alla violenta reazione che ebbe nei loro confronti dopo poco, allora quella lettura degli eventi cambiò repentinamente e gli stessi che prima festeggiavano iniziarono a parlare degli attentati come di fatti organizzati ad hoc dal governo americano stesso con lo scopo di avere un motivo per attaccare il mondo arabo. Iniziarono così a farsi strada una serie di fake news e racconti, con ipotesi strampalate senza alcun fondamento, che presentavano un’altra verità rispetto a quanto accaduto e che fecero breccia anche in Occidente. Ovviamente l’avvento dei social è stato il motore che ha permesso la diffusione su larga scala di queste teorie sull’11 settembre, ma non solo: oggi, ad esempio, con il coronavirus stiamo vivendo la stessa cosa.
BARDAZZI: Credo sia ingiusto assegnare agli americani il ruolo di inventori della teoria dei complotti, basti pensare come nei Promessi Sposi Manzoni dedicò due capitoli ad una vera e propria inchiesta giornalistica per smontare l’idea degli untori che portavano la peste a Milano: già lì c’era tutto, dalle fake news ai no vax. Di complotti l’umanità ha sempre vissuto, da Nerone ad oggi: di certo ciò che è avvenuto è stata una proliferazione evidente di questo fenomeno con l’avvento dei social. Per quanto riguarda le teorie sull’11 settembre, ma più in generale delle fake news, credo che l’anno chiave sia il 2006: Facebook si apre a tutti, nasce Twitter, Google News comincia a disintermediare distribuendo le notizie dei giornali gratuitamente. Io sono convinto che qui nascano le teorie dei complotti sugli attentati, non nel 2002 o 2003: i social media hanno permesso la diffusione dei contenuti di quei blog che parlavano di queste ipotesi strampalate, sono nate così le prime community che grazie ai primi algoritmi si sono autoalimentate. Questi nuovi strumenti ovviamente hanno poi permesso la proliferazione su larga scala non solo dei complotti sulle Torri Gemelle ma anche il riemergere delle tesi più disparate su JFK, sullo sbarco sulla Luna ecc… fino ad arrivare all’eccesso degli ultimi anni con le teorie come quella di Q-Anon che hanno portato all’assedio del 6 gennaio scorso a Capitol Hill. È un tema interessante poiché, appunto, può provocare gravi conseguenze.
DAHLER: Penso che le teorie della cospirazione esistano da quando gli umani hanno imparato a parlare. Oltre a JFK ci sono altri clamorosi esempi: è risaputo infatti come ci sia ancora oggi chi insiste sul fatto che lo sbarco sulla luna non sia mai avvenuto. Resta però sorprendente per me la misura in cui certe persone siano arrivate addirittura a dubitare che l’11 settembre sia accaduto o sia successo nel modo in cui tutti l’abbiamo visto. Sono stato contattato qualche anno dopo i fatti da un documentarista europeo che voleva mostrarmi il suo film attraverso il quale, secondo lui, era riuscito completamente a smentire le conclusioni ufficiali sull’11 settembre 2001. Mi ha raccontato di aver trascorso innumerevoli ore ad analizzare le dirette televisive di quel giorno, compresa la mia, e ha cercato di dimostrare che era tutto falso, che le immagini degli aerei che si schiantano contro gli edifici sono state generate al computer. Tutto ciò è palesemente assurdo e ignora completamente l’esistenza di centinaia di migliaia di persone sul campo a New York quella mattina che hanno assistito agli eventi con i propri occhi. Per quanto riguarda le fake news penso invece siano un’invenzione più recente e siano nate a causa di un certo presidente degli Stati Uniti a cui non piaceva la copertura fattuale delle sue azioni. Che ruolo hanno giocato i media nel diffondere queste? I media non sono un’entità singolare, ma sono composti da legioni di persone diverse, di diversa provenienza, istruzione, pregiudizi e influenze, tutti elementi che hanno un certo effetto sulle loro prospettive e sui rapporti. Credo che la stragrande maggioranza dei giornalisti cerchi di fare bene il proprio mestiere in ogni occasione nonostante questi tratti personali, ad eccezione delle agenzie di stampa create negli ultimi decenni per promuovere un’agenda politica di destra che ignora la verità.
Che 11 settembre 2001 si immagina se fossimo già vissuti nell’era dei social media?
BORRELLI: Credo che con i nuovi media nati negli anni successivi all’11 settembre quel giorno saremmo giunti al delirio più totale. Certo, già allora vi erano le prime manifestazioni di internet, ma il dominio televisivo e dei giornali nel mondo dei mass media e dell’informazione era praticamente totale. È importante sottolineare come questo dominio vi fosse sia in Occidente che in Medio Oriente: anche lì i grandi network giocarono un ruolo decisivo nelle considerazioni maturate all’interno dell’opinione pubblica.
BARDAZZI: Vivevamo in un’epoca dove la diffusione delle immagini con i social media non era quella alla quale siamo abituati adesso. Per i giovani del 2021 è difficile immaginarlo ma i nostri telefonini non facevano le foto e non vi è stata perciò quella ricchezza di documentazione che sarebbe stata possibile oggi; anzi, a tal proposito porto ancora il rammarico di non aver avuto con me una macchinetta fotografica quel giorno. Nonostante questo le immagini di quel giorno sono comunque veramente tante, anche perché – mi si passi il termine – ad essere colpito è stato il luogo più fotogenico del mondo e con la maggiore presenza di network internazionali rispetto ad ogni altra città. Dal punto di vista della copertura giornalistica una comparazione può essere fatta con eventi simili all’11 settembre 2001 che abbiamo vissuto successivamente, questa volta sì con gli strumenti digitali a portata di mano: Parigi, Londra e gli attentati dell’ISIS sono stati tutti raccontati anche attraverso il ricorso ai new media. Mi immagino perciò che la narrazione dell’attentato di New York sarebbe stata in qualche modo simile, ovviamente ancora più angosciosa di quanto sia stata poiché ci saremmo trovati tutti lì attraverso le testimonianze live di chi era sul posto. Penso però allo stesso tempo che sarebbe stato più difficile riuscire ad avere una narrazione condivisa: il problema di quest’epoca è avere una narrazione coerente. Il punto non è avere un mondo dei media che di fronte a un 11 settembre ti bombardi con tante immagini da non capirci più niente, quanto invece mettere insieme tutte le informazioni per farne uscire un giudizio di massima nel quale tutti si possano ritrovare e sviluppare così, solo successivamente, le proprie considerazioni personali.
DAHLER: Beh, innanzitutto gli eventi sarebbero stati inevitabilmente documentati da ogni angolazione immaginabile e da migliaia di smartphone, probabilmente anche in streaming live sui social media: a proposito di teorie del complotto, penso che i fanatici della cospirazione avrebbero avuto molte difficoltà a smentire i fatti. Inoltre posso dire con certezza che oggi non sarei vivo se allora avessi avuto con me il mio iPhone. Il primo istinto che ebbi quella mattina, dopo aver chiamato la redazione per riferire ciò a cui avevo assistito, è stato quello di prendere la mia videocamera e correre negli edifici insieme ai vigili del fuoco della caserma dei pompieri che si trovava al piano terra del mio condominio: per qualche strano motivo però non riuscii a trovare la macchina fotografica nel cassetto dove la tenevo sempre e così i pompieri partirono senza di me. Se avessi avuto uno smartphone sarei potuto comunque salire lo stesso con loro su una delle due torri: la maggior parte di quei pompieri non è stata mai più vista…
Com’è cambiata la società alle 8 e 46 di quel martedì di vent’anni fa? La parabola dell’Occidente ha subito una deviazione irreparabile o con il passare del tempo è riuscita a tornare nell’orbita iniziale?
BORRELLI: La società è inevitabilmente cambiata perché è cambiato il modo di vivere. La nostra vita è stata stravolta non in termini indefiniti ma nella tangibilità del quotidiano: dai controlli per viaggiare all’obbligo di dover esibire un documento di identità per recarsi in un albergo. È inoltre emersa una contrapposizione tra mondo occidentale e parte del mondo islamico, nei sistemi di vita, che dopo l’11 settembre si è accentuata ancora di più. Nell’immediato lo shock fu fortissimo, tanti locali restarono chiusi per molto tempo e ognuno di noi fu costretto a rivedere le proprie abitudini e a dover fare delle rinunce. Con il passare del tempo poi la gente è tornata a vivere una situazione di normalità, ma sempre con la paura del terrorismo che da quel martedì mattina accompagna le nostre vite. Possiamo fare un paragone con la pandemia che stiamo vivendo: con il lockdown siamo stati costretti a rivedere ogni nostra azione quotidiana, successivamente la vita è ripresa ma sempre limitata e condizionata dalla presenza del virus. Ebbene anche nel caso dell’11 settembre si può parlare di un virus, ovvero quello della paura e del terrorismo, che non è stato ancora debellato ed è sempre con noi. Ciò che l’uomo può fare è imparare a convivere con queste nuove realtà.
BARDAZZI: Mi piace il paragone dell’orbita perché l’11 settembre 2001 è stato come un asteroide che ci è venuto addosso: il pianeta ha traballato e riportato delle conseguenze enormi da tanti punti di vista. Penso che siano tre i grandi asteroidi che hanno colpito la Terra in questo periodo: uno è l’attentato al World Trade Center, gli altri due – più dilatati nel tempo ma allo stesso modo in grado di dar vita ad un cambiamento irreversibile – sono internet e i cambiamenti climatici. Parlo di asteroidi perché penso che l’effetto di quegli aerei che si infilano sulle Torri Gemelle e sul Pentagono sia stato epocale quasi da segnare il passaggio da un’era all’altra. Con l’11/9, quanto meno in una prima fase, si è tornati ad avere una lettura del mondo quasi svanita: finita la guerra fredda, si aveva l’impressione che l’unico compito fosse costruire il mondo perfetto libero da nemici. Quell’attentato ha invece riportato tutto in discussione. È interessante notare come l’11 settembre, altro non sia che il materializzarsi dell’eterno scontro nei secoli di storia tra l’Islam e il Cristianesimo: siamo tornati quindi a doverci confrontare con cose che hanno radici addirittura nell’VIII secolo. È stata questa la grande frenata imposta da quest’asteroide, il quale ha ricordato al mondo intero “attenzione, ti stai occupando della globalizzazione e della new economy scordandoti però della storia e di temi su cui dovrai continuare a confrontarti a distanza di millenni”. Io definirei perciò l’11 settembre 2001 come il “ritorno della storia”: storia non solo intesa come economia o finanza, ma come l’insieme di tante cose molto più profonde. Credo che questo sia stato il segno più profondo lasciato da quegli attacchi, tanto è vero che ancora oggi ci troviamo in uno scenario di nuovo simile. Cosa ci sta dicendo la storia? Che nonostante tutte le nostre accelerazioni impostegli non dobbiamo dimenticare le radici di ciò che ha segnato il corso dei secoli.
DAHLER: Penso che in quel momento tutti noi abbiamo perso l’innocenza che avevamo ancora quella mattina, in termini di sicurezza dal male e dalla violenza a cui tante altre persone, in tutto il mondo, erano già soggette ogni giorno. Credo che ci siamo dovuti rendere conto che tutti i caccia, i carri armati, le armi nucleari e i soldati non possono proteggerci da persone determinate – a qualunque costo – a causare danni per una causa politica. La definizione stessa di guerra è stata ampliata. Ma, a parte l’aumento della sicurezza aeroportuale e dei posti di blocco all’ingresso dei grandi eventi pubblici, non sono poi così sicuro che la vita in generale di un americano o di un occidentale sia stata stravolta così drammaticamente dagli attacchi di quella mattina di vent’anni fa: andiamo ancora a fare shopping, vediamo film (seppur con la mascherina!), giochiamo con i nostri cani in cortile, il centro di Manhattan è pieno di gente e i grattacieli brulicano di uomini e donne che fanno affari. In tutto ciò però è innegabile che ci sia sicuramente una consapevolezza di fondo circa il fatto che la vita sia un po’ più fragile.
New York e il mondo intero celebra questo anniversario con la cerimonia solenne al 9/11 Memorial Museum: vent’anni dopo le ferite sono state rimarginate? Il mondo è riuscito a voltare pagina?
BORRELLI: L’11 settembre 2021 è un giorno molto triste anche a causa della riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, la quale porterà molti – tra cui i familiari dei militari uccisi in guerra – a chiedersi se lo sforzo compiuto in questi anni in termini di vite umane e di risorse economiche sia servito veramente a qualcosa. E’ perciò un momento di riflessione, di dolore ma anche di amarezza e delusione perché di nuovo al potere si trova chi diede ospitalità ad Al-Qaeda e permise loro di pianificare quegli attentati. Credo anche che il presidente Biden abbia voluto accelerare – a questo punto in modo improvvido – la ritirata dall’Afghanistan proprio per arrivare alla data di questo anniversario con lo slogan di “mission accomplished”, cosa che purtroppo così non è. E’ un anniversario 11 di ferite aperte e cicatrici non rimarginabili.
BARDAZZI: È interessante e significativo vedere come gli americani riescano a far memoria di certi eventi. Se pensiamo al 9/11 Memorial, il concorso per la sua realizzazione fu vinto da una coppia di creativi che immaginarono le due vasche “senza fondo” con l’acqua che vi entra dentro; altrettanto significativo è come per costruire l’intera area e la Freedom Tower si siano affidati a Daniel Libeskind, ovvero l’architetto ebreo che ha progettato anche il museo ebraico a Berlino. Tutto ciò fa capire come sia stata data una chiave di lettura particolare ed è rilevante come chi abbia vissuto il dramma dell’olocausto e abbia una cultura come quella ebraica riesca ad aiutare e a dare un’interpretazione ancora più forte di quanto saremmo stati in grado di fare da soli. Il rischio più grande di questo 11 settembre è quello di etichettare come inutile tutto ciò che è stato fatto in vent’anni: penso ai militari, alle famiglie delle vittime degli attentati e dei marines uccisi, agli operatori delle ONG, agli afghani stessi. Certo, la sensazione che tutto sia stato vano è difficile da cancellare e togliere di dosso. Mi auguro che questo ventesimo anniversario venga letto in chiave storica, poiché la storia ha tempi lunghi ed è molto più complessa di come noi tendiamo a leggerla, spesso in maniera semplicistica. Quindi così come è stato sbagliato celebrare la missione compiuta in Afghanistan da parte di Bush dopo la fuga dei talebani, allo stesso modo penso sia sbagliato essere totalmente catastrofisti oggi. Questi vent’anni un segno l’hanno lasciato, ma lo vedremo solo con il passare del tempo. Un 11 settembre 2021 nel quale non si deve passare la giornata a piangersi addosso bensì a cercare di guardare magari con speranza al trentennale.
DAHLER: Sinceramente no, non credo che il mondo abbia voltato pagina. Di attacchi terroristici ce ne sono ancora tutti i giorni in ogni parte del pianeta, condotti da persone disposte a uccidere per le loro idee. Questa è una triste realtà che esiste sia su grande che su piccola scala in tanti Paesi. In America avvengono attacchi terroristici quasi con cadenza giornaliera, sebbene la stragrande maggioranza di essi non siano condotti da terroristi islamici ma da suprematisti bianchi di estrema destra.
L’ultima. Chiuda gli occhi e provi ad immaginarsi un mondo nel quale l’11 settembre 2001 quell’attacco non sia mai avvenuto e il cielo azzurro di New York non sia stato macchiato dalle nubi nere color morte. Che realtà immagina?
BORRELLI: È difficile da immaginare. Sicuramente sarebbe stato diverso per New York, ma credo che il problema di fondo sarebbe comunque rimasto. L’11 settembre 2001 si è verificata la manifestazione di un fenomeno che esisteva già e che aveva radici ben profonde, dunque temo che se non fosse stato a New York prima o poi un atto di quella matrice si sarebbe verificato o in America o in qualunque altra parte dell’Occidente. L’attacco alle torri, il loro crollo, le fiamme e la fitta nube su Manhattan, nonché le migliaia di vittime morte in quella maniera hanno reso tutto più tragico e più vero, ma quella realtà di odio che si è manifestata esisteva, esiste ancora ed è profonda. Non a caso dopo New York eventi simili sono avvenuti in Spagna, a Londra, a Parigi. Ecco perché dico che sì, possiamo chiudere gli occhi per immaginare un mondo diverso ma non dobbiamo invece chiudere gli occhi difronte al fatto che questa realtà non si è spenta, ci odia e continua a considerarci come un nemico. L’elemento di riflessione è che con questa realtà dovremo ancora continuare a fare i conti, vent’anni dopo quel martedì mattina dove tutto è cambiato.
BARDAZZI: La mia impressione è che se quell’attentato fosse stato sventato ne avremmo vissuto comunque qualche altro, magari più avanti nel tempo rispetto al 2001, con la stessa matrice. Anzi, penso che neppure la possibilità di sventarlo all’ultimo minuto ci avrebbe permesso di aumentare così tanto il livello d’attenzione pari a quello raggiunto. Sarebbe probabilmente successo qualcos’altro: sappiamo che le alternative alle quali stava pensando Al Qaeda erano chimiche o nucleari, il che avrebbe reso la cosa allo stesso modo tragico e devastante. Se quel bellissimo martedì di settembre due aerei non avessero colpito le torri, un terzo velivolo il Pentagono e un quarto non si fosse schiantato al suolo, qualcos’altro del genere ci sarebbe comunque piombato addosso, dobbiamo farcene una ragione. Mi piacerebbe immaginare però un mondo totalmente diverso per esempio in merito a quanto avvenuto in Iraq, dove venne fatta una scelta fuori misura e fuori bersaglio, così come avvenuto per tanti altri errori commessi dall’America, vedi Guantanamo che vent’anni dopo continua ad essere ancora lì.
DAHLER: Vorrei poter dire che avremmo goduto di due decenni di pace e prosperità. Le migliaia di famiglie che quel giorno hanno perso i propri cari li avrebbero visti tornare a casa quella notte e sarebbero invecchiati insieme. Anche le centinaia di migliaia di civili in Afghanistan e in Iraq che sono morte nelle guerre successive avrebbero potuto sopravvivere e continuare le loro vite. E ancora, i soldati e i marines americani morti in combattimento avrebbero visto per loro un futuro. Dico questo non essendo sicuro che tutto ciò possa essere però realistico: c’è così tanta rabbia, odio e risentimento nel mondo che penso fosse inevitabile che prima o poi le nostre coste sarebbero state raggiunte, in una forma o nell’altra. Le dolorose lezioni apprese l’11 settembre 2001 prima o poi, un giorno o l’altro, sarebbero state imposte a questa nazione, proprio come sono già state insegnate attraverso lacrime e spargimento di sangue a tante altre persone in tutto il mondo.