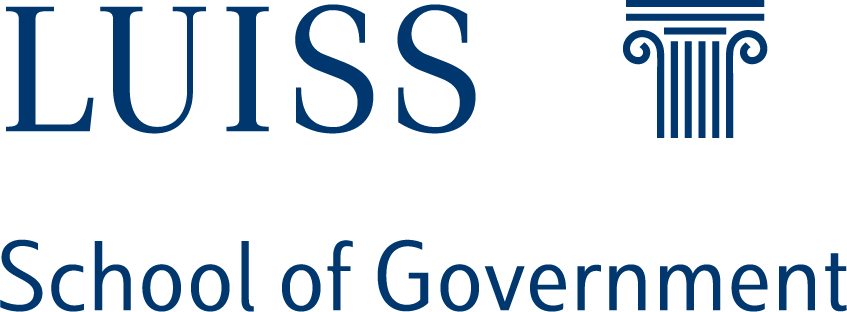È l’attualità che detta i tempi a brand e spot

Lockdown society e advertising. Domanda e offerta provano a incontrarsi su un terreno in cui percezioni mediate e immediate, esperienze dirette e indirette, bisogni e aspirazioni si rincorrono di continuo per collocarsi in una dimensione a matrice circolare, conseguenza manifesta del superamento dei processi lineari tipici della postmodernità. Non sappiamo cosa accadrà all’homo economicus dopo la fine di questo “fatto sociale totale”, come l’Associazione Italiana di Sociologia ha definito la pandemia utilizzando una vecchia espressione di Marcel Mauss. Sappiamo, però, che specie da quando il marketing ha provato a raccogliere i vantaggi del suo graduale scivolamento in direzione del societing, la pubblicità ha cambiato postura.
Negli ultimi quattro mesi l’interazione tra brand e mercato si è trasformata in conversazione sul “consumo di senso”, per dirla con de Certau, e intorno al riconoscimento delle priorità collettive così come determinate dal precario vissuto individuale. La marca, diventa costrutto socio-culturale a maggior ragione in tempi di coronavirus, ha fatto stretching.
È uscita dal contesto naturale in cui vive per immergersi nella quotidianità emergenziale, secondo una traiettoria sviluppatasi in linea con programmi di corporate social responsability e di sostenibilità ambientale e in piena continuità con le logiche di stabilizzazione della brand reputation. In queste giornate di distanziamento fisico interpersonale (ma non sociale!) il marketing si è fatto real-time e newsjacking, recependo e rielaborando contenuti provenienti dall’attualità. I brand hanno “agganciato” le notizie non solo per aumentare awareness, attitude ed equality e condizionare la purchase intention dei consumatori, ma anche per stazionare dentro il flusso. Stazionare con l’intento di contribuire alla gestione del presente e alla proiezione nel futuro, di generare engagement e di rafforzare il senso d’appartenenza alle proprie community, tematizzazione del dolore e del disagio, ma anche voglia di riscatto e di riparazione, grazie ai ponti semantici costruiti tra aspettative delle persone e value proposition aziendale.
I brand sono poggiati sulla categoria della resilienza, sul valore del lavoro svolto in condizione di pericolo, sul rapporto di collaborazione tra dipendenti e management, sulla centralità della famiglia in quanto territorio identificativo solido da contrapporre a quello più fragile della società pandemica, hanno dispensato consigli su come comportarsi nel concreto (Eni). Hanno sottolineato il ruolo sociale della tecnologia come strumento indispensabile per perseguire l’obiettivo della connessione e della comunicazione (Tim e Vodafone). Hanno sollecitato gesti di generosità e creato attenzione verso campagne già in atto (Foxy). Si sono appellati all’identità nazionale (Ferrarelle) e fatto evolvere la nostalgia in energia. Come avrebbe detto Goffman, il mondo dell’advertising ha trasformato gli “spazi di retroscena” in “spazi di palcoscenico”, rappresentando la vita di tutti noi all’interno delle mura domestiche. Mura proposte non come un limite, ma come l’opportunità di attivare una rinegoziazione di significati pandemici nel perimetro delle dinamiche oppositive d’interno/esterno, basso/alto, stretto/largo, corto/lungo, negativo/positivo (Febal, Monini). Negli sport andati on air e online sono stati coinvolti dipendenti e collaboratori sulle cui spalle è ricaduto il peso della rappresentazione in chiave eroica di questa “guerra” al virus. Sono stati coinvolti gli italiani affacciati dai balconi: luoghi minuscoli, eppure proposti come nuova sfera pubblica mediatica (Barilla, Esselunga, MD, Carrefour). È stata data visibilità a chi lavora nell’ombra assecondando le trame imposte dallo “spirito tenace” di questo tempo (La Molisana) e a chi ha reso la cucina di casa un vero e proprio hub esperienziale (Star). Sono stati metti in evidenza gli utenti delle piattaforme digitali raffigurati dentro i quadratini minuscoli e colorati di videoconferenze cresciute di numero in coerenza con le logiche della prosumerizzazione (vodafone e mulino bianco). Sono state proposte best practices di resistenza attraverso il ricorso a testimonial simbolo di sfide senza limiti, di risultati straordinari raggiunti con la sola forza della volontà (Bmw). Si è fatto ricorso all’effetto heritage non tanto in chiave di legacy quanto come struttura narrativa s cui edificare ottimismo e speranza, partendo da una cultura sedimentata nell’immaginario collettivo e collocato in un altrove diacronico (Lavazza). Tutte attività di riempimento di vuoti svolte dentro e fuori i recinti della pubblicità, come avvenuto per esempio con quelle aziende (Lardini) che, da subito, hanno finalizzato la propria produzione tessile alla realizzazione di migliaia di mascherine al giorno, da donare gratuitamente alla popolazione. Tra i brand che hanno raggiunto il maggiore favore degli utenti vi sono quelli che hanno saputo riconvertire parte del proprio business nella produzione di dispositivi di protezione o in valvole per respiratori polmonari (Ferrari).
Le diverse comunicazioni pubblicitarie hanno fatto leva su alcuni “oggetti di valore” come l’accettazione con responsabilità delle limitazioni alle libertà personali, la visione prospettica in favore di un orizzonte diacronico di superamento delle emergenze che pure facciamo fatica a individuare, il senso di solidarietà. È stato fatto tutto ciò, correndo però un doppio rischio: il trionfo della retorica e dell’omologazione di forme espressive e messaggi. Almeno nel periodo di lockdown, la pubblicità ha ridotto le distanze tra le marche. Ha parlato lo stesso linguaggio, dando per scontato che vi fosse un unico meeting point tra brand, consumer e stockholder. Un humus popolato da vettori del senso assai simili tra loro che hanno mantenuto le distanze dalla “forma merce”. Il discorso pubblico e discorso pubblicitario hanno coinciso favorendo, dal punto di vista socio-semiotico oltre che di content marketing, il primato di convenzionalità e sovra-testualità. Da una parte c’è stato un “dire per essere creduti”. Dall’altra un “riconoscersi per crederci”. Riconoscersi nell’uniforme e monolitica rappresentazione pandemica per credere al ripristino della normalità. Ammesso sia ciò che vogliamo davvero.
Articolo precedentemente apparso sul Sole 24 Ore. Riprodotto su Luiss Open il 7 giugno 2020