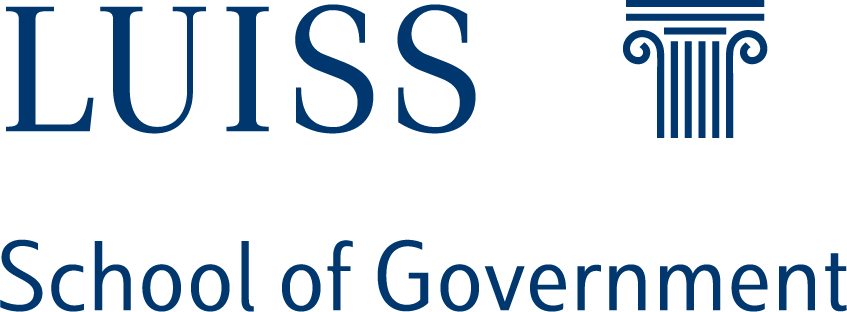Femminicidi e media. Se la vittima diventa colpevole
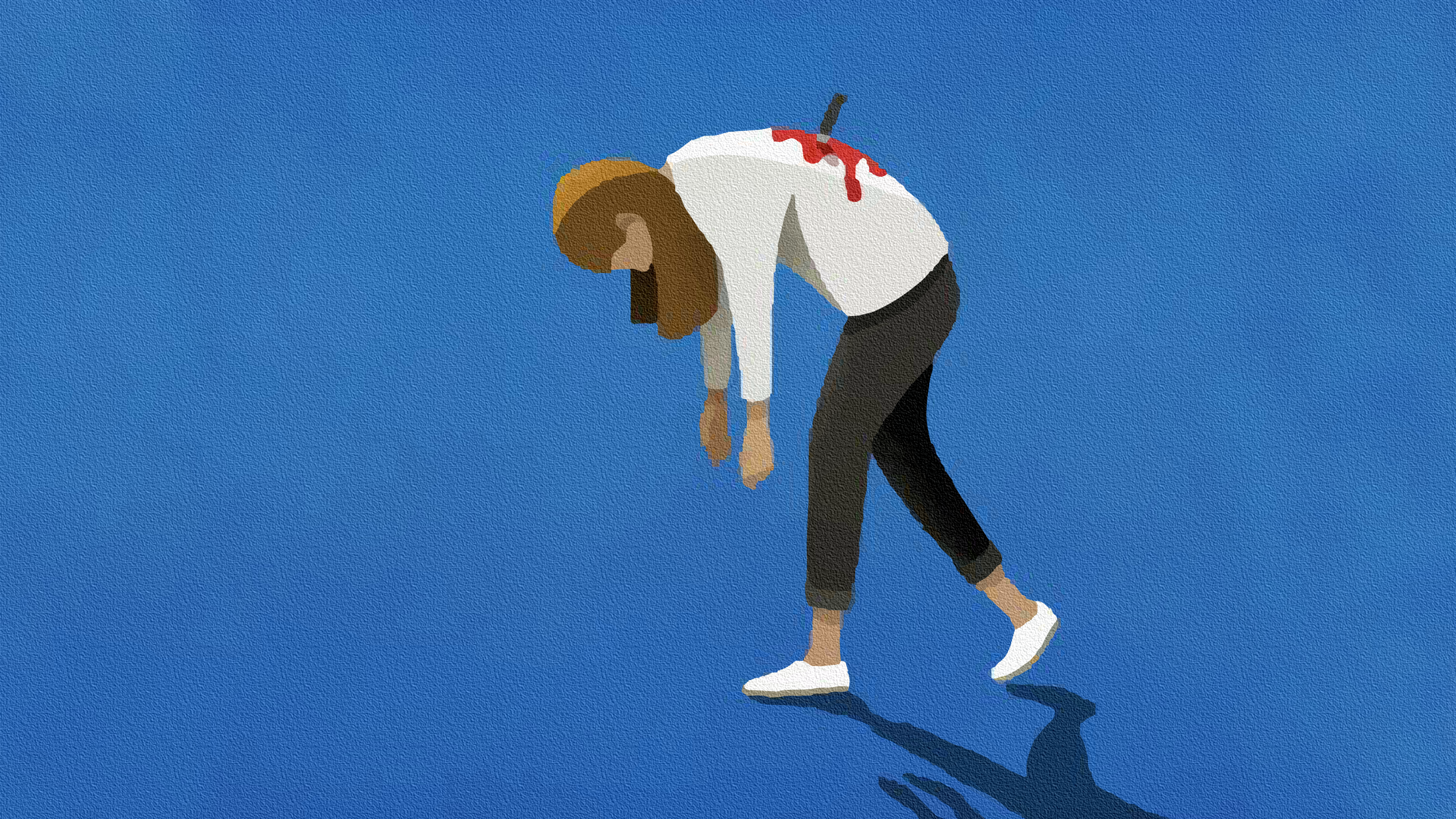
di Alessandra Staiano
“La parola è quasi sempre pronta, quando è pronto il concetto” sosteneva negli anni Trenta in “Pensiero e Linguaggio” Lev Semenovic Vygotskij, pioniere della psicologia cognitiva. Non c’è dubbio che il termine “femminicidio” sia una parola nuova, coniata nel “mondo femminista” per indicare l’origine culturale e il carattere strutturale di un fenomeno presente da secoli. Non c’è dubbio neanche che sia entrata a far parte in Italia del discorso mainstream dopo la ratifica nel 2013 della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale posto a tutela delle vittime di violenza di genere giuridicamente vincolante per i Paesi UE. Di femminicidio si è parlato più insistentemente, dunque, soprattutto quando il concetto si è trasformato in norma.
Quella parola calata nella narrazione giornalistica ha perso l’ampiezza della sua portata semantica originaria e ha, paradossalmente, provocato il reiterarsi e l’amplificarsi di stereotipi stigmatizzati proprio da quell’area che aveva cominciato a dibatterne. Su tutti, il victim blaming, ovvero la colpevolizzazione della vittima attraverso, ad esempio, titoli che individuano il movente nelle scelte delle donne (“lei voleva lasciarlo”) e che rimandano a una giustificazione, neanche poi così tanto implicita, per l’autore del delitto. A ciò si aggiungano titoli giornalistici che interpretano l’atto letale come l’estrema conseguenza di un conflitto, posto che presentano la violenza come una “reazione” invece che come una “azione”, le cui ragioni vanno ricercate, secondo quanto sostenuto dalla Convenzione di Istanbul, nella discriminazione delle donne in ogni campo della società e non soltanto nell’ambito della psicologia del singolo uomo violento.
L’utilizzo del frame dell’amore romantico, con il ricorso ad espressioni quali ‘raptus’ o ‘motivi passionali’ caratterizza da tempo il discorso giornalistico, come dimostrato da numerose ricerche, ma anche da indagini e sentenze giudiziarie. Per il disvelamento degli stereotipi adottati dalla magistratura appare prezioso il contributo della giudice Paola Di Nicola, in particolare con il testo del 2018 “La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio”. Testo nel quale si passa in rassegna una serie di decisioni processuali fortemente segnate dal ricorso, appunto, a stereotipi di genere.
Le cronache giornalistiche dei femminicidi spesso sono accompagnate da polemiche su questi aspetti. Il caso dell’imprenditore Alberto Genovese accusato nel novembre 2020 dello stupro di una 18enne durante una festa nella propria residenza milanese (lui descritto come “geniale inventore di start-up di successo” e lei come “una che in fondo se l’è cercata”) è solo l’episodio più recente. E di certo non sarà l’ultimo.
Per il giornalismo è soprattutto una questione deontologica che ha acquisito crescente centralità grazie al costante lavoro dell’associazione Gi.U.Li.A. e che ha visto nel 2017 la firma del Manifesto di Venezia, la realizzazione di diversi seminari tematici nei programmi di formazione professionale continua promossi dall’Ordine dei Giornalisti e l’inserimento di un apposito articolo nel recente Testo Unico dei Doveri del Giornalista in vigore dal primo gennaio 2021.
Va notato che la rappresentazione del fenomeno risulta falsata non solo dal “come” esso viene raccontato, ma anche dalla scelta delle storie da raccontare. L’Osservatorio di ricerca sul femminicidio, attivo presso l’Università di Bologna, ha rilevato come a fare notizia, anche per più giorni, siano prevalentemente le uccisioni di donne giovani per vicende rispetto alle quali è possibile creare suspence in una logica di adesione ai processi tipici del newsmaking. Le storie relative ad altre vittime, adulte o anziane, semmai arrivano ai titoli di quotidiani o dei tg, scompaiono presto dal ciclo della produzione delle news. Inoltre, mentre l’Istat rileva che il fenomeno riguarda ogni fascia d’età, la Convenzione d’Istanbul dedica molta attenzione a migranti e richiedenti asilo. L’attuale Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, infine, ha un focus specifiche sulle disabili.
Anche quando la narrazione giornalistica è attenta a non colpevolizzare la vittima c’è il rischio che la rappresentazione dell’uomo maltrattante come “carnefice-mostro” faccia percepire la violenza di genere come qualcosa di lontano dalla vita quotidiana del pubblico. Una tendenza che ostacola la piena comprensione del fenomeno molto più diffuso nelle sue varie manifestazioni di quanto si creda. Si pensi alla prima ricerca Istat realizzata sul tema nel 2014 che rilevò che 3 donne su 10, nella fascia 16-70 anni, avevano subìto violenza nel corso della propria vita.
Il tema dei dati è una nota dolente. Attualmente non esiste un unico punto di raccolta delle informazioni relative alla violenza di genere presenti negli archivi di Tribunali, forze dell’ordine, ospedali, centri antiviolenza, case rifugio. Il Senato a novembre del 2020 ha approvato all’unanimità una legge che mira a garantire un flusso informativo costante sulla violenza maschile contro le donne per “progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno”.
La frammentarietà e la disomogeneità dei dati certamente non aiutano la sfera pubblica mediata a rappresentare il fenomeno a pieno e in modo più aderente alla realtà. Fanno il resto, da un lato i processi produttivi del newsmaking con le tipiche spinte alla semplificazione e alla spettacolarizzazione e dall’altro gli stereotipi di genere fortemente radicati nella società italiana. Nel 2019 l’Istat ha rilevato che il 32,5% della popolazione ritiene che per l’uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro; che il 31,5% ritiene gli uomini meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche; che il 27,9% afferma che è l’uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia, solo per citare alcuni dei dati più significativi.
Sul versante delle altre forme di racconto mediale, nell’ambito del più ampio tema della rappresentazione delle donne in Tv e nella pubblicità, pure rilevante ai fini di questa riflessione, vanno segnalati due aspetti. In Tv la violenza di genere è trattata prevalentemente attraverso la storia di coloro che non ce l’hanno fatta, con trasmissioni come “Amore criminale” fortemente criticate dalle associazioni di genere per l’accusa di voler spettacolarizzare la violenza medesima. Lella Palladino, già presidente della rete nazionale D.i.Re, in cui confluiscono oltre 80 associazioni di genere che gestiscono Centri Anti Violenza in tutta Italia, rimarca l’esigenza di un approccio neutro che metta a fuoco la genesi della violenza strettamente connessa, secondo l’assunto della Convenzione di Istanbul, alla storica disparità tra i sessi in ogni campo della vita sociale, economica e culturale. Ciò per essere d’aiuto nel processo di trasformazione culturale del Paese che è, invece, l’unica strategia efficace per il completo superamento della violenza di genere.
Nel campo della pubblicità c’è da rilevare anche, come fa Renata Kodilja, la presenza di una sorta di “sessismo benevolo”, categoria introdotta da Glick e Fiske con la proposta di un modello teorico del “pregiudizio di genere” che nasce dalla consapevolezza dell’ambivalenza dei rapporti tra i generi. Se il sessismo ostile si riferisce alla percezione delle donne che cercano “il controllo sugli uomini sia attraverso la sessualità, sia attraverso l’ideologia femminista”, il sessismo benevolo è invece una forma più subdola e condivisa dalle stesse donne che si fonda sull’idea che le donne siano “creature pure che dovrebbero essere protette, sostenute e adorate dagli uomini e il cui amore è necessario per rendere completo un uomo”.
La narrazione mainstream nel mondo dell’informazione e della comunicazione appare lontana dalle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul che tra gli obblighi degli Stati aderenti prevede campagne di sensibilizzazione al fine di “aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza”. Ci si riferisce, dunque, non soltanto alle manifestazioni estreme con le loro conseguenze letali ma anche al resto. Si sollecitano i media ad adottare linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare così finalmente il rispetto della loro dignità.