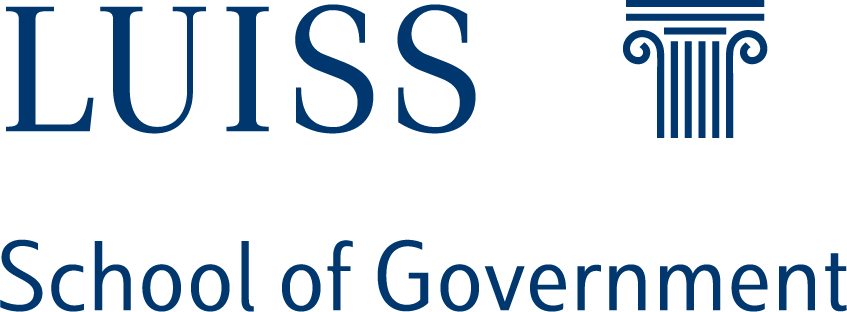Gli Europei, i diritti, la potenza simbolica dello sport. E il ruolo dei brand

di Stefano Calogero
1968, Olimpiadi di Città del Messico: sul podio i velocisti Tommie Smith e John Carlo alzano al cielo i pugni inguantati di nero durante l’inno americano. Sono anni caldi e la lotta per i diritti passa anche attraverso lo sport. 2021, Europei di calcio itineranti: le squadre in ginocchio prima delle partite in adesione al movimento Black lives matter, le bandiere arcobaleno pro Lgbt, ancora sport e lotta per i diritti. Gesti e comportamenti che dai campi di calcio sono piombati subito nel dibattito interno dei Paesi. La politica è stata chiamata in causa, partiti e istituzioni hanno discusso e sono intervenuti a loro volta con azioni di sostegno o di disapprovazione. E inevitabili cortocircuiti comunicativi. La potenza simbolica dello sport.
E i brand? I brand non restano più a guardare, mettono al centro delle loro preoccupazioni i problemi sociali e spesso invadono il campo della politica. Soprattutto sul tema Lgbt, anche per via della concomitanza con il Pride Month di giugno, il mondo della pubblicità si è allineato. Agli Europei molti cartelloni a bordo campo sono stati riempiti con i colori arcobaleno, sui social i loghi hanno seguito la trasformazione cromatica.
L’edizione del torneo continentale posticipata di un anno causa Covid sarà ricordata come la più politicizzata di sempre. Lo sport è un palcoscenico efficace in questi casi. Il gesto di piegarsi in segno di protesta, d’altronde, porta la firma di Colin Kaepernick, il giocatore di football americano che a partire dal 2016 cominciò ad inginocchiarsi all’esecuzione dell’inno nazionale per protestare contro le ingiustizie subite dalla minoranza nera negli Usa. Seguì l’ira di Trump, il mancato rinnovo del contratto ad uno dei migliori quarterback in circolazione e la scelta di Nike di ingaggiare l’atleta come testimonial della storica campagna Just do it, evoluta semanticamente nel tempo fino a diventare un invito ad agire per cambiare le cose, per un valore.
Tanto per parlare di brand che intervengono su temi sociali e tornando agli Europei, va detto che le squadre sono apparse divise sul comportamento da tenere prima delle gare. In Francia si è alzato un polverone politico e alla fine i Blues hanno scelto di non inginocchiarsi contro il razzismo, come del resto altre Nazionali. Alcune, come Belgio, Inghilterra e Galles, hanno invece aderito senza tentennamenti. Altre ancora, come l’Italia, hanno mostrato incertezza: prima no, poi sì ma in parte, e ancora dopo il sì compatto ma solo in segno di solidarietà agli avversari. Anche nel nostro Paese la questione ha stimolato il dibattito politico, mentre la Figc ha lasciato libertà di scelta ai giocatori. Il pubblico presente negli stadi, invece, ha avuto reazioni differenti. Una parte ha apprezzato, anche se non sono mancati i fischi. Proprio sul tema del razzismo gli Europei hanno avuto una coda velenosa. I giocatori inglesi di colore, dopo la finale persa contro l’Italia, sono stati presi di mira sui social per aver sbagliato un semplice calcio di rigore. Nike, tornando ai brand, ha ritwittato il comunicato di condanna della Federazione calcistica inglese, Adidas ha scritto un messaggio di solidarietà citando un tweet del Manchester United a difesa del calciatore Marcus Rashford.
Anche sulle iniziative pro Lgbt, durante il torneo continentale, non sono mancati momenti di tensione. Il caso che ha fatto più discutere si è verificato prima della gara fra Germania e Ungheria, quando il sindaco di Monaco di Baviera ha chiesto di illuminare lo stadio con i colori arcobaleno. Un modo per manifestare il dissenso nei confronti di una recente legge voluta dal governo di Orban che di fatto mette sullo stesso piano omosessualità e pornografia. L’Uefa ha imposto lo stop «a causa del contesto politico della richiesta», salvo poi colorare d’arcobaleno il proprio logo sui social, quasi a volerci mettere una pezza. Adidas, per tutta risposta, il giorno dell’incontro ha twittato una foto del capitano della Nazionale tedesca Manuel Neuer con la fascia arcobaleno al braccio. Un messaggio forte accompagnato da una frase altrettanto chiara: «For the love of sport and the love of love, football is ready». Ancora i brand in primo piano, dunque, poco preoccupati di metter bocca su temi divisivi. Restando nel campo della comunicazione, non è passata inosservata anche la decisione della Lega Serie A di colorare il logo a sostegno dei diritti Lgbt negli account Twitter di lingua italiana, spagnola e inglese ma non araba, vista la sensibilità dei Paesi mediorientali sulla questione. Hanno optato per la stessa linea anche la Juventus e marchi noti come Microsoft e Mercedes, ad esempio. Le iniziative pubblicitarie delle aziende sui temi Lgbt, per motivi come questo, spesso vengono accostate al rainbow washing, considerate perciò solo di facciata.
L’attenzione che molte imprese riservano ai problemi sociali, in ogni modo, è sempre più forte. È vero che le reazioni dei consumatori in alcuni casi sono negative e provano a far venire fuori l’interesse che sta dietro le strategie di marketing, ma è altrettanto evidente che le scelte in alcuni casi anche coraggiose delle aziende, accompagnate da atti concreti, raccolgono molti apprezzamenti. C’è un chiaro tentativo di intercettare le istanze che provengono dai consumatori, specie giovani, sempre più interessati a quello che i brand sono disposti a fare per incidere e cambiare la società. Non si tratta più di semplici attività di responsabilità sociale. Non è più sufficiente avere solo un buon purpose, molte imprese hanno capito che è necessario agire per mantenere le promesse “sociali”. È il modello del brand activism (Kotler e Sarkar, 2020). I brand si muovono su terreni roventi e prendono l’iniziativa, soprattutto se le istituzioni rimangono a guardare.
Il caso prima citato, Nike che sceglie Colin Kaepernick come testimonial, è uno degli esempi che Kotler e Sarkar mettono in risalto. Il colosso americano, in quell’occasione, scelse di andare contro il presidente Trump, vide bruciare le scarpe con il proprio logo in segno di disapprovazione, ma alla fine ne uscì vincente. Un aumento delle vendite, ma anche la certezza di avere davvero inciso in quel preciso frangente e di aver raccolto il consenso di una parte di America. Proprio Nike, uno dei principali bersagli della celebre denuncia No logo di Naomi Klein (2000) per lo sfruttamento dei lavoratori. I tempi cambiano, insomma, anche se la strada è lunga e in tanti non sono ancora disposti a dar credito alle aziende. Che, ostinate, proseguono.
Si diceva in apertura di Tommie Smith. Puma, proprio ispirandosi a quel gesto simbolo alle Olimpiadi del 1968, 50 anni dopo ha creato una piattaforma per supportare tutti coloro che si adoperano per combattere le disuguaglianze. Azioni come queste bastano per rendere credibile l’impegno di chi le promuove? È questa la sfida più grande che chiama in causa non solo le imprese, ma anche i governi e le istituzioni, le loro scelte sui temi cruciali e il loro modo di gestire la potente leva della comunicazione.