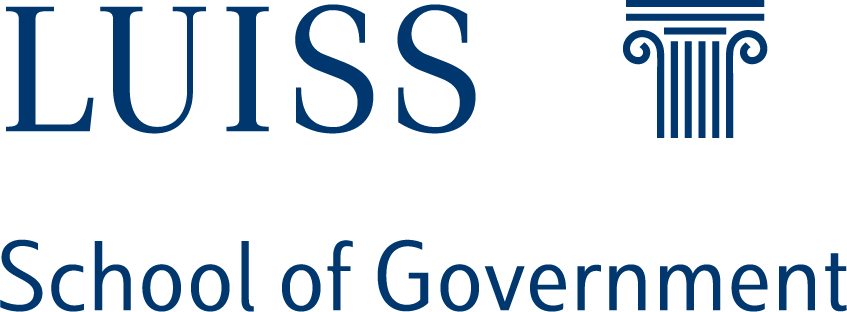Il filibustering negli Usa tra passato e presente

di Fabio Massoli
Seguire le vicende politiche americane di queste settimane significa imbattersi, sicuramente e ripetutamente, in un particolare tema di discussione tra le parti che riguarda non tanto il dibattito politico circa la sostanza delle proposte quanto invece un preciso tecnicismo procedurale: il filibuster o filibustering. Cosa si intende con questo particolare termine? E perché tutti ne discutono? Per spiegarlo è opportuno partire da lontano, con alcuni elementi da chiarire a priori.
Prima doverosa premessa. L’iter legislativo negli Stati Uniti d’America, in mano al Congresso, prevede che un disegno di legge debba essere approvato da entrambe le Camere prima di essere inviato al Presidente, il quale avrà a disposizione dieci giorni di tempo per firmarlo oppure respingerlo, ponendo così il suo veto, rispedendolo indietro affinché si proceda alla sua modifica. È interessante notare, a tal proposito, come cambino radicalmente i criteri di regolamentazione del dibattito in aula e la soglia di voti necessari per l’approvazione di una proposta di legge tra una Camera e l’altra. Per ciò che riguarda il primo punto, se alla Camera dei Rappresentanti sono previste delle regole sulle tempistiche degli interventi, al Senato non vi sono invece limiti: questo comporta il fatto che, alla Camera alta, le parti sono ogni volta costrette a venirsi incontro o per stabilire un “time agreement” o per mettere in atto dei meccanismi procedurali denominati “cloture”, salvo rischiare di ritrovarsi in caso contrario coinvolti in situazioni di oggettiva impasse. Secondo punto: se alla Camera bassa (composta da 435 deputati) è necessaria una maggioranza semplice per l’approvazione un disegno di legge, anche in questo caso al Senato la situazione è diversa dato che, fatta eccezione per le leggi di bilancio nelle quali è sufficiente una maggioranza semplice di 51 voti, per approvare una qualsiasi legge è necessaria quella che è definita come “super maggioranza” e che consiste in una soglia minima di 60 voti su 100. Volendo essere ancora più precisi e addentrandoci nei vorticosi tecnicismi legiferativi americani, mettiamo in evidenza che per approvare una legge servono 51 voti, ma per decidere se votare su quella legge, di voti ne servono 60. Citando un vecchio spot commerciale si potrebbe dunque dire che “sixty is the magic number”, la soglia di sicurezza per non rischiare di vedere naufragare un bill.
Seconda doverosa premessa. Il Senato degli Stati Uniti è costituito da 100 seggi, divisi egualmente tra i cinquanta Stati: ogni Stato dell’Unione è rappresentato dunque da 2 senatori. Il motivo di questa suddivisione, e l’annesso dibatto circa la proficuità di tale scelta, è rintracciabile sin nei giorni della stesura della Costituzione: le colonie più piccole, come il Rhode Island e il Connecticut, diedero vita ad un’aspra battaglia per vedersi rappresentate nello stesso modo degli altri in almeno una delle due Camere. La distanza tra le parti era tale che la situazione fu più volte sul punto di degenerare, facendo venir meno il tentativo di nascita della nuova Repubblica: alla fine esse ebbero la meglio ed oggi, volenti o nolenti, il Rhode Island, che conta circa un milione di abitanti, ha lo stesso numero di senatori della California che di abitanti ne ha 40 volte tanto. Dunque è evidente che questa difformità comporti una non veridicità delle reali proporzioni demografiche (e di scelta di voto) degli stati all’interno del Senato.
Terza doverosa premessa. La maggioranza degli americani appare essere sempre più democratica. Lo dicono i dati. Lo dicono gli oltre 81 milioni di voti raccolti da Biden (record di sempre) rispetto ai 74 milioni del repubblicano Trump alle ultime elezioni presidenziali. Lo dicono quei segmenti della popolazione (afroamericani, latinos, ecc.) che se ieri erano minoranze, oggi invece non lo sono più. Si tratta di cittadini più propensi di ieri a votare per il Partito Democratico. Se questi numeri vengono in qualche maniera rappresentati correttamente alla Camera dei Rappresentanti (anche se metodi come il gerrymandering possono alterarne la veridicità al momento del voto), la composizione del Senato fa sì che, come appena visto, questa disparità non venga mantenuta nelle proporzioni. Con quale conseguenza? Con la conseguenza che ogni elezione porta al formarsi di maggioranze – siano esse democratiche o repubblicane – sempre risicate e soprattutto, ai fini del nostro ragionamento, ben lontane dal magic number prima citato.
Quarta ed ultima doverosa premessa. La politica americana e parallelamente le posizioni elettorali dei cittadini statunitensi sono oggi estremamente polarizzate. Un processo iniziato trent’anni fa e che ora vede una situazione difficilmente recuperabile dal punto di vista del raggiungimento del “compromesso tra le parti”. L’evidente radicalizzazione della classe politica, ma anche di certa stampa e tv, è riconducibile alla dottrina teorica presentata dal sociologo Jeffrey Alexander, il quale fa riferimento ad un uno schema cognitivo di tipo binario, nel quale si è assistito alla “costruzione di una rappresentazione della politica in grado di restituire anzitutto il senso della distinzione tra un “noi” e un “loro”, tra buoni e cattivi, tra equi e iniqui, tra giusto e ingiusto, tra valore e disvalore” (Giorgino, 2021). Negli Stati Uniti tutto ciò ebbe inizio negli anni Novanta e Duemila, quando contemporaneamente a fatti storici favorevoli per lo sviluppo di questo tipo di rappresentazione estrema, un numero sempre maggiore di attori interni al mondo politico provarono a spostare sempre più in là l’asticella della componente moderata. Se tra i democratici l’ala socialista, guidata da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, sembra la meno propensa a giungere a mediazioni con gli avversari, tra i repubblicani questa tendenza appare addirittura più evidente. Da Newt Gingrich a Sarah Palin, dal Tea Party a Ted Cruz e Donald Trump, l’estremizzazione del “noi contro loro” ha trovato terreno fertile nella proliferazione di canali tv pronti a raccogliere e fomentare questa tipologia di storytelling politico, ben consci dei grandi profitti in termini di ascolti che essi avrebbero raccolto. Come un grande ingranaggio, la polarizzazione tra le due parti ha coinvolto tutti i protagonisti, compresi ovviamente i cittadini elettori, sempre più divisi in due tifoserie contrapposte.
Partire da queste premesse era importante perché esse fanno da fil rouge per spiegare cosa sia il tema oggetto della presente analisi: un Senato con una maggioranza limitata ha bisogno che le due parti giungano ogni volta a compromessi per arrivare ai 60 voti necessari ma, in un contesto politico americano sempre più polarizzato e radicalizzato, tale prospettiva non è la cosa più frequente nelle aule del Congresso. Ecco che allora la super maggioranza diventa un miraggio irraggiungibile che lascia spazio alle insidie della maggioranza semplice, tra le quali da sempre ce n’è una che sembra andare più di moda delle altre: l’ostruzionismo parlamentare o, appunto, il “filibustering”.
La storia del filibuster è curiosa e particolare, nonché vecchia quanto il Senato stesso. Già nel 1789, a poche settimane dall’entrata in vigore della Costituzione, il senatore della Pennsylvania William Maclay annotava sul suo diario il tentativo dei colleghi virginiani di fare ostruzionismo parlando ininterrottamente per ore. È nella seconda metà dell’Ottocento però che questa pratica diventa così frequente durante le attività in aula da meritare l’etichetta di “filibuster”, termine derivante dallo spagnolo “filibusteros”: erano i terribili pirati che razziavano le navi commerciali nel mare dei Caraibi. I problemi iniziarono ad emergere durante il periodo dell’espansionismo verso Ovest, quando l’annessione di nuovi Stati nell’Unione e il conseguente aumento dei membri del Senato portò ad un lievitare talmente grande del lavoro da sbrigare che le pratiche di ostruzionismo rischiavano di bloccare pericolosamente l’intero iter. La diabolica genialità di questa tecnica parlamentare approfitta infatti di quanto detto circa l’assenza di regolamentazione dei tempi massimi di intervento al Senato. Visto che un disegno di legge non può essere messo ai voti prima che la discussione in aula non si sia conclusa, i senatori all’opposizione hanno la possibilità di procedere con dei veri e propri interventi fiume per ritardare ed ostacolare la votazione. Per ovviare a questo problema nel 1917 si pensò, su sollecitazione del presidente Woodrow Wilson, di adottare una nuova regola ad hoc (Rule 22): essa consentiva, nel caso i due terzi del Senato fosse stato favorevole (tetto minimo poi abbassato a 60), di invocare una “cloture” e porre un limite massimo al tempo degli interventi. Anche con questa nuova regola però il filibustering rimaneva un mezzo efficace per bloccare la legislazione, dato che era assai difficile ottenere i due terzi dei voti. Nel corso degli anni tale tipo di ostruzionismo si è rivelato utile alle minoranze di turno, ad esempio ai senatori del Sud che cercavano di bloccare le leggi sui diritti civili, comprese le proposte contro il linciaggio. Soltanto nel 1964, caso celeberrimo nella storia politica americana, il Senato a maggioranza democratica riuscì a superare con successo un ostruzionismo feroce dei repubblicani per approvare quelle leggi che avrebbero poi portato allo storico “Civil Rights Act”.
Ma come si fa a parlare per ore ed ore? E soprattutto di cosa si parla? La storia del filibustering racconta di temi bizzarri all’ordine del giorno, tra i quali un karaoke, la lettura delle ricette tipiche della Louisiana, l’elenco telefonico di Washington D.C. o alcune tra le più belle favole della buonanotte. Anche questa pratica nel corso degli anni si è comunque evoluta e si è perciò passati dal cosiddetto talking filibuster al più recente virtual filibuster. Come spiega Arnaldo Testi, docente di Storia degli Stati Uniti, oggi è infatti sufficiente solamente minacciare, da parte di uno o più senatori, la volontà di procedere con l’ostruzionismo per bloccare di fatto una legge: niente stoiche e storiche maratone oratorie alla Jefferson Smith – celebre personaggio del film datato 1939 di Frank Capra “Mr. Smith Goes to Washington” citato anche in un episodio dei Simpson – cittadino qualunque divenuto senatore e il quale, per impedire l’approvazione di una legge corrotta, parlò per ben venticinque ore concludendo con l’iconico “Somebody’ll listen to me” prima di svenire esausto (nella realtà il record appartiene a Strom Thurmond, senatore della Carolina del Sud che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minuti). Più di mezzo secolo dopo c’è chi prova ancora ad avventurarsi in lunghi discorsi senza fine, ma l’abitudine oramai affermatasi è quella di affidarsi al meno nobile ostruzionismo virtuale, quello minacciato ma mai realizzato comodamente dal divano di casa. Lo stesso presidente Biden pochi giorni fa, criticando l’abuso dei repubblicani circa le continue minacce di fare ostruzionismo al Senato – e che mettono in serio pericolo la sua agenda politica (gran parte dei democratici oggi sono sul piede di guerra a suon di “Eliminate the Filibuster!”) – ha ironicamente suggerito un ritorno all’ostruzionismo tradizionale: “Se proprio volete bloccare una legge, metteteci un po’ d’impegno fisico: parlate, parlate, parlate, fino a crollare collassati. Quando sono entrato in Senato io, 120 anni fa (con annessa risata guascona), era consuetudine fare così. E indovinate un pò? La gente si stancava di parlare e si stancava di collassare. E così l’ostruzionismo finiva”.
La domanda che sorge allora spontanea è: perché non eliminare definitivamente il filibustering? Perché, al di là di tutto, alle parti sino ad ora è andata bene così. Le maggioranze infatti, si sa, non sono eterne, ma vanno e vengono. Una volta si può stare in maggioranza e una volta dopo si può stare all’opposizione. Una volta perciò l’ostruzionismo può essere uno strumento contro i propri interessi mentre un’altra può essere un utile alleato per le proprie battaglie in aula. Il fatto che il filibuster possa sempre tornare comodo in futuro ha fatto sì che, nonostante sia necessaria una maggioranza semplice di 51 voti per cancellarlo, nessuno abbia mai fatto sul serio per procedere alla sua rimozione dalla prassi politica americana. Ad esempio – anche oggi che i democratici hanno sulla carta quei 51 voti – la questione resta comunque di difficile lettura, dato che l’essere favorevoli o meno a questa pratica elude dallo schieramento di appartenenza. Oggi infatti diversi senatori del partito dell’asinello sono scettici o contrari alla sua cancellazione. Ne consegue che una legge – o addirittura di conseguenza un’intera agenda – che sia oggetto di ostruzionismo da parte dell’opposizione quasi sempre rischia di naufragare al Senato, soprattutto oggi che, a causa della polarizzazione delle due parti, è estremamente difficile convincere un numero sufficiente di avversari a cambiare posizione. E questo in situazioni di lame duck (anatra zoppa, termine riferito ad un Presidente con una parte del Congresso contro) può danneggiare seriamente l’iter legislativo del Paese. Storia americana e di “filibustieri” che, quantomeno, tornino però ad essere veramente tali, in nome e in memoria delle venticinque ore di Jeff Smith.