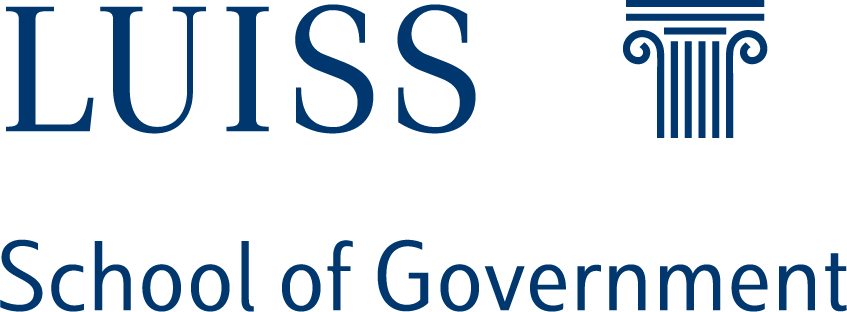Il tweet di Zingaretti e il politainment

di Francesco Giorgino
La giornata di mercoledì 24 febbraio era di quelle delicate. La maggioranza doveva decidere quale metodo adottare per potenziare l’azione di contrasto alla diffusione del virus, specie nelle sue varianti più pericolose. Occorreva inoltre completare la composizione della squadra di governo con la nomina dei sottosegretari, anche al fine di non dare la sensazione che la formula mista tecnici-politici non sia tanto un fattore di opportunità, quanto una minaccia alle ragioni della stabilità. Eppure il leader del Pd Nicola Zingaretti ha trovato il tempo e il modo di fare un tweet, che ha sollevato non poche polemiche. Un tweet in cui si scrive testualmente: “@carmelitadurso (che sta per Barbara D’Urso, ndr) in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro ha portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!” Segue l’hashtag #noneladurso. La “notizia appiglio” del cinguettio del numero uno dei Dem era l’indiscrezione della chiusura in anticipo del programma domenicale di prima serata della D’Urso. E, quindi, a meno che a scrivere il tweet non sia stato un hacker (come qualcuno ha ironizzato sul web), è probabile che alla base di questa decisione vi sia stata la voglia di testimoniare amicizia e apprezzamento per il lavoro svolto dalla stakanovista delle reti Mediaset.
Non è di questo che, però, vogliamo parlare. Anche perché chi scrive sostiene da tempo la tesi che ognuno è libero di pensare quello che vuole e di fare la televisione come vuole. Una delle forme più alte di democrazia è, del resto, quella del telecomando. Il punto è un altro. Da un lato riguarda quella parte del tweet in cui Zingaretti fa riferimento alla necessità di “portare la voce della politica vicino alle persone”. Dall’altro riguarda il numero elevato di reazioni negative, a riprova del fatto che il tweet ha toccato un nervo scoperto, specie nell’ambito del centro-sinistra.
Volendo inquadrare il tema all’interno dei modelli più recenti della comunicazione e del marketing politico il richiamo più naturale è alla teoria del politainment. Teoria elaborata per la prima volta dal politologo David Schultz e poi adottata a più riprese dagli studiosi del rapporto media-politica. Politainment è un neologismo che deriva dalla fusione di due parole inglesi: politic (in quanto sistema politico) ed entertainment (in quanto intrattenimento, specie di tipo televisivo). Il politainment è un genere, ovvero una tipologia di contenuto mediale, come tale riconoscibile sia dagli emittenti sia dai riceventi. E’ un framework grazie al quale far riferimento da una parte alla presenza di esponenti politici nella sfera pubblica mediata attraverso le enfatizzazioni, in linea peraltro con i processi di costruzione di leadership comunicativa e carismatica, degli elementi personali di chi ha responsabilità pubbliche; dall’altra all’uso dei codici dell’intrattenimento nella rappresentazione della politica. Situazione quest’ultima spintasi fino alla volontà di individuare (e gestire) veri e propri format in grado di contenere e stabilizzare nel tempo gli intrecci di tale ibridazione, come ad esempio è accaduto con House of Cards su Netflix. Questa seconda opzione interpretativa coincide anche con le espressioni “politica pop”, “spettacolarizzazione della politica”, ma anche “storytelling politico”.
L’Italia è stata la culla del politainment. Nella prima repubblica abbiamo visto la politica misurarsi con gli spettacoli del Bagaglino e prima ancora con le imitazioni di Alighiero Noschese in prime time. Anche quello era un modo per essere (o quanto meno per apparire) più prossimi ai cittadini. Nella seconda repubblica ci siamo nutriti dei racconti coinvolgenti generati in second time dal Maurizio Costanzo Show, abbiamo assistito alla discesa in campo di Berlusconi costruita sul presupposto di un uso sapiente del mezzo televisivo e abbiamo ammirato a Porta a Porta D’Alema cucinare il risotto o Amato giocare a tennis. Nella terza repubblica abbiamo sorriso durante lo streaming tra Beppe Grillo e Matteo Renzi, ma anche in occasione della partecipazione di quest’ultimo (all’epoca esponente di primissimo piano del Pd) al programma “C’è posta per te” di Maria De Filippi con tanto di giubbotto di pelle nera alla Fonzie. E non solo.
Sono stati ospiti di Barbara D’Urso i leader di tutti i partiti e schieramenti, ma anche molti rappresentanti delle istituzioni. Ci sono andati durante le fasi pre-elettorali e durante il primo lockdown, mostrando di essere a loro agio con l’uso del “tu” anziché del “lei”. Nessuno ha mai sollevato alcun problema. I palinsesti televisivi da anni sono costruiti mescolando temi d’intrattenimento a questioni d’attualità, specie politica. Una dinamica trasversale a tutte le reti televisive e presente in tutte le fasce orarie. Volendo parafrasare Macdonald, siamo immersi nella “midcult”, via di mezzo tra la cultura alta e la cultura bassa, che può sì coincidere con la cultura di massa (“masscult”) ma che ambisce altresì a strutturarsi come segmento a sé, reggendosi sulla rinegoziazione dei significati all’interno di habitat costruiti per adesione alla dittatura del mercato.
Stupisce, dunque, che ci si stupisca. Salvo che lo stupore sia dovuto solo all’autore del tweet e alla sua destinataria. E, quindi, salvo che, nel contempo, non si voglia affermare che la D’Urso è un’eccezione alla regola anziché la conferma che la regola è ormai irreversibile o salvo che si voglia insistere con il teorema della (presunta) superiorità culturale della sinistra. In questo caso il problema sarebbe rappresentato solo dall’imbarazzo del Pd (non avvertito, tuttavia, dal suo leader) non solo nel riprodurre quelle prassi coltivate in nome dell’esigenza della riduzione delle distanze tra elettorato attivo e passivo, tra rappresentante e rappresentato, tra élite e popolo, ma anche nel celebrarne la sua legittimità fino all’elevazione a paradigma.
Non sprechiamo questa occasione. Piuttosto concentriamoci su quale direzione vogliamo prenda il rapporto tra media e politica, tra televisione e potere. E riflettiamo su quale debba essere il ruolo del giornalismo che sta ricevendo dal pubblico non più la delega, come avveniva in passato, a selezionare il materiale notiziabile ma a monitorare l’intero flusso comunicativo. Il tweet di Zingaretti e la querelle sulla chiusura anticipata di uno dei programmi della D’Urso passerà. Resterà invece il tema della titolarità dell’informazione da parte dei giornalisti e dell’esigenza di non annacquare i tratti distintivi di una professione che si fonda su competenze tematiche, espressive, tecniche e deontologiche. La confusione dei ruoli non giova a nessuno: né agli intrattenitori, né ai giornalisti. E la politica può avvicinarsi all’opinione pubblica anche lavorando sui contenuti, anziché optare solo per i contenitori.