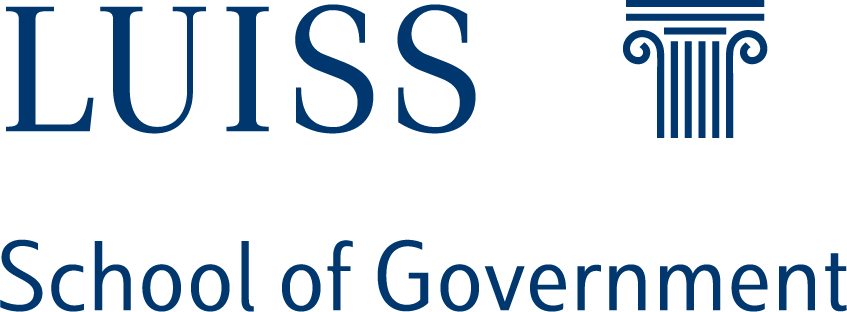La metamorfosi dei social network dopo il caso Trump

Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la Sociologia della Comunicazione negli ultimi decenni è stato quello di riflettere sulla differenza che passa tra una concezione dei media come “tecnologie” ed un’altra più articolata, anche perché finalizzata a mettere in evidenza le diverse forme di comunicazione e le diverse tipologie d’azioni, le regole in vigore e quelle auspicate, i modelli organizzativi e gli assetti burocratici più adoperati, il legame con la proprietà, il grado di autonomia di chi elabora e distribuisce i contenuti, i fattori economici ma anche quelli politici e culturali alla base dei processi produttivi. Quanti significati ha il sostantivo “medium” e quante sono le opzioni in campo di questa parola di origine latina, volendo procedere ad una classificazione degli strumenti a nostra disposizione per comunicare in modo efficace, come d’obbligo nell’era tardo-moderna. Tutto ciò, specie se si consideri non solo la prospettiva diacronica, in base al principio di contestualità spazio-temporale, ma anche quella sincronica. In fondo, si tratta di un uso della téchne, dilatato nel suo significato platoniano (Bolter, 2009) di “abilità a fare qualcosa” e quindi di conoscenza/competenza necessarie per governare la digital transformation e gestire il primato dei new media. Un ambito quest’ultimo dove, a partire dal 2004, si sono affermate piattaforme usate (e/o usabili) o per rafforzare reti di contatti personali o per trasmettere e fruire contenuti in una logica in grado di collocarsi a metà strada tra la produzione e il consumo. Naturalmente parliamo del consumo produttivo e di quello di senso. E’ in questo contesto che si inserisce la discussione scaturita dopo la decisione di Twitter di sospendere a tempo indeterminato l’account @realDonaldTrump e temporaneamente quello della Casa Bianca @Potus (acronimo che sta per President of The United States).
E’ doverosa una premessa prima di andare avanti con il ragionamento. L’atteggiamento assunto da Donald Trump dopo la vittoria di Joe Biden e soprattutto in occasione dell’assalto a Capitol Hill di alcuni suoi supporter è assai grave. È lontano dalla logica istituzionale che dovrebbe contraddistinguere l’operato del Presidente di un Paese che ha sempre avuto l’ambizione di essere punto di riferimento per le democrazie di tutto il mondo. E’ opportuno, tuttavia, leggere la mossa di Twitter, così come del resto quella di Facebook nei giorni precedenti, con chiavi interpretative più elaborate di quelle utilizzate in base a disegni di iper-semplificazione e in momenti della storia ad alta emotività.
L’8 gennaio 2021 può considerarsi una data spartiacque tra un “prima” e un “dopo”. Youtube, Snapchat, Spotify, TikTok non sono stati da meno e Amazon, Apple e Google hanno disconnesso l’app Parler. Il dibattito ha coinvolto non solo mediologi, studiosi della Rete, politologi e filosofi, ma anche rappresentanti istituzionali e politici di diversi Paesi. La Merkel ha parlato di scelta “problematica”, sostenendo che i limiti alle libertà fondamentali possono arrivare solo dalle leggi. Perplessità sono state espresse anche in Francia dal ministro dell’Economia Le Maire e nelle sedi dell’Unione Europea: oltretutto, non più tardi di un mese fa la Commissione era stata chiamata a pronunciarsi sul Digital Services Act. Il timore ora è che si crei un precedente pericoloso. Non sono mancati gli effetti tangibili di queste decisioni: considerando le reazioni di Wall Street possiamo sostenere che i giorni successivi al blocco dell’account di Trump, Facebook e Twitter hanno avuto un vero e proprio tonfo sui mercati. Conviene, dunque, a tutti una riflessione a freddo.
Come sosteneva Levi Strauss, a volte le domande sono più utili delle risposte, che peraltro in questo caso sarebbero parziali e provvisorie, posto che nessuno di noi può prevedere l’evoluzione della situazione americana da qui al 20 gennaio e l’impatto che le ultime mosse di Trump avranno sull’elettorato repubblicano, tutt’altro che demotivato.
Se assumessimo il punto d’osservazione degli analisti più critici del Presidente uscente, dovremmo limitarci a chiederci perché la decisione di Twitter sia stata così tardiva. Alec Ross, già consigliere all’innovazione della sfidante di Trump, ovvero Hillary Clinton, ha di recente evidenziato che i social network sono passati direttamente dalla passività alla messa al bando e che se il Tycoon non avesse perso, essi non si sarebbero comportati alla stessa maniera. Volendo, invece, assumere una postura ermeneutica più neutra e più in linea con la copiosa letteratura scientifica in materia di platform society è assai più utile domandarci se e quanto la decisione dei Big Tech, ovvero di aziende private e non certo di Autorità pubbliche di regolamentazione, siano compatibili con il principio del free speech. Principio che è la naturale esplicazione del primo emendamento della Costituzione americana e dell’articolo 21 della nostra Carta. Nel ricordarlo, è utile e giusto annotare che la libertà di manifestazione del pensiero ha assunto una differente dimensione operativa passando dall’era analogica a quella digitale.
Articolando meglio le domande, ci si chiede se il timing della decisione presa dalla proprietà del social cinguettante sia compatibile con la natura di Twitter e degli altri social network, con la logica disruptive dello status quo antecedente all’arrivo dei new media. Non era anch’essa una logica da outsider dell’ecosistema comunicativo, proprio come Trump lo è stato e lo è rispetto all’establishment politico americano? E’ giusto che aziende private detengano così tanto potere?
Le motivazioni di Twitter, ovvero l’esigenza di scongiurare il pericolo di un “ulteriore incitamento alla violenza” così come la consapevolezza che “le persone in posizione di potere non possono considerarsi al di sopra delle regole”, sono consistenti sotto il profilo formale. Generano, tuttavia, alcune riflessioni in ordine ai rischi (o ai vantaggi, dipende dai punti di vista!) della metamorfosi dei social network e social media in media mainstream. Il web, specie nella versione 2.0, nasce e si sviluppa sul presupposto della massima libertà di opinione e soprattutto della determinazione a dis-intermediare o a re-intermediare contenuti prodotti in una prospettiva di co-creazione da parte degli utenti. E’ questa la meccanica esecutiva dei personal media, i quali a fini di marketing politico hanno agevolato l’applicazione di strategie di micro targeting e a fini di comunicazione politica la produzione di messaggi non più solo one to many, ma anche one to one, many to many e many to one. Una meccanica in totale contrapposizione, nonostante i molti processi di ibridazione in atto, a quella degli old media, alimentatisi negli anni attraverso la presenza di frame in grado di condizionare la rappresentazione della realtà. E’ difficile, dunque, o quanto meno troppo disinvolto, accostare la mission di una televisione generalista o di un gruppo editoriale offline e online alla proprietà di una piattaforma nata e concepita per orizzontalizzare (e non certo per verticalizzare) la produzione e la fruizione di tutti i contenuti. E che ha puntato ad implementare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e la presenza dei soggetti politici nella sfera pubblica, strutturando una quasi ideologia, in nome della quale abbiamo consentito che alla “utopia dell’informazione per tutti” del XX secolo subentrasse “l’utopia dell’informazione da parte di tutti” ad inizio del nuovo millennio e che si attenuasse, un po’ per opportunismo e un po’ per abitudine, il fastidio e la preoccupazione per echo chambers, filter bubles e, per dirla con Khaneman, per il “pensiero veloce”. Anzi, per il pensiero velocissimo, a basso impegno cognitivo e fonte della riproduzione all’infinito di percorsi virali, indipendentemente dalla effettiva qualità dei contenuti selezionati.
Il dibattito sulla funzione dei social network rispetto alla conquista e al consolidamento del consenso elettorale cominciò a svilupparsi prima della presidenza Trump, anche se va sottolineato che da parte sua, insieme con uno sfruttamento in chiave di personal branding e di market oriented party (per dirla con Lees-Marshment), vi è stato sovente un uso sgrammaticato (istituzionalmente parlando), specie quando proteso alla denigrazione degli avversari, persino con qualche episodio di fake news.
Twitter era (usiamo l’imperfetto perché è stato egli stesso a comunicare la volontà di creare una propria piattaforma digitale) il medium preferito da Trump: non a caso a metà 2015 aveva già 2,8 milioni di follower, cresciuti in modo esponenziale negli anni successivi sino da arrivare ai quasi 89 milioni del giorno di chiusura dell’account. Fu The Donald, del resto ad ammettere, una volta arrivato alla Casa Bianca quattro anni fa, che senza Twitter non sarebbe diventato Presidente degli Stati Uniti. Più che ragionare intorno al paradosso di Popper, in base al quale in nome della tolleranza non si possono tollerare gli intolleranti, bisognerebbe forse più semplicemente partire da questo dato di realtà.
Articolo precedentemente apparso su Luiss Open il 14 gennaio 2021