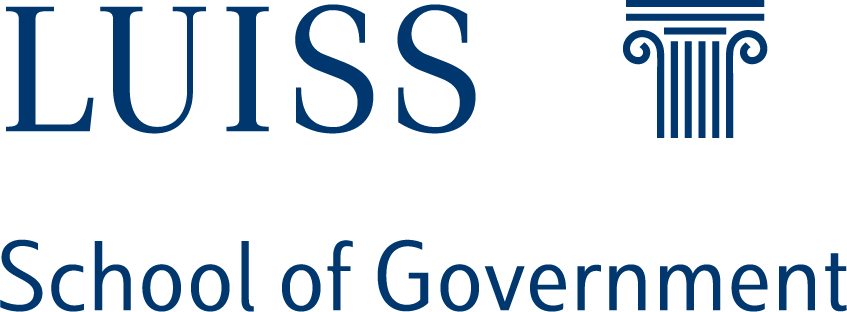L’Associazione Laureati Luiss intervista Francesco Giorgino, Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale

Interrogato sui principali temi della contemporaneità e sulle sfide per il presente e futuro della comunicazione e dell’informazione, il Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale, Prof. Francesco Giorgino, ha rilasciato una lunga intervista per il portale dell’Associazione Laureati Luiss che riproponiamo di seguito ai nostri lettori.
Gli ultimi due anni hanno visto sovrapporsi ed in un certo senso avvicendarsi due eventi di portata epocale come la pandemia e la guerra in Ucraina. Quali affinità e quali differenze vede tra i due eventi dal punto di vista della narrazione da parte dei media?
Anzitutto direi che il termine più capace di restituire il senso della complessità dell’attuale frangente storico è quello di “sovrapposizione” tra questi due eventi, certamente di portata globale. Pandemia e conflitto in Ucraina sono eventi completamente diversi tra loro, determinati da condizioni non accostabili dal punto di vista eziologico ed analitico per alcuna ragione, se non per la valutazione degli effetti sui pubblici dei media e sulle opinioni pubbliche nazionali e internazionali dei processi di rappresentazione e autorappresentazione delle attività di decision making.
Lei mi sollecita a cogliere i profili di affinità e a segnalare le differenze nella narrazione mediale di questi due accadimenti. Le rispondo schematicamente, partendo dalla maggiore, se non dall’unica affinità esistente a mio giudizio, ovvero quella della presenza in entrambe le situazioni del modello della comunicazione emergenziale. Con questa espressione, nei media studies, ci si riferisce a quella tipologia di comunicazione costretta a misurarsi, almeno nella fase primordiale, con l’inaspettatezza, con l’imprevedibilità, insomma con la difficoltà ad utilizzare quelle chiavi interpretative collaudate in condizioni di normalità. Ma anche a misurarsi con la straordinarietà, con la varietà degli effetti conativi e prima ancora degli effetti cognitivi ed emozionali. Caratteristiche queste che valgono sia nella comunicazione di massa, sia in quella istituzionale o d’impresa.
Un ambito di applicazione di questo paradigma è individuabile persino nella comunicazione interpersonale e di gruppo, ma è evidente come la dimensione macro sia quella più pertinente rispetto al tipo di analisi che stiamo sviluppando in occasione di questa intervista. Nella gestione della comunicazione emergenziale rilevano la strategia messa in campo, le tipologie dell’ecosistema comunicativo, le forme di distorsione volontaria o involontaria, i pericoli connessi a situazioni di deragliamento del senso, il tasso di emotività, le abilità previsionali, l’uso dei dati, la capacità di costruire una forma di racconto che superi l’enorme difficoltà della frammentarietà e della parcellizzazione delle informazioni. Gli step più rilevanti dal punto di vista della comunicazione emergenziale solitamente sono: conoscenza del contesto nuovo, specie quando esso si presenta senza preavvisi; consapevolezza dei rischi connessi alla situazione venutasi a creare in modo, appunto, inaspettato; call to action, specie su sollecitazioni delle istituzioni nazionali e internazionali, per individuare la risposta più tempestiva e, se è possibile, anche quella migliore con l’intento di archiviare in fretta la dimensione emergenziale; valutazione dei comportamenti individuali e collettivi; creazione nel medio e lungo termine di una “cultura della risposta” allo stato di crisi.
Non è un caso che nella letteratura scientifica si colga la presenza di una saldatura concettuale tra la parola “emergenza” e la parola “crisi”. La prima indica l’atto dell’emergere di qualcosa, il momento critico che richiede un intervento immediato. La seconda, la parola “crisi”, fa riferimento a quei cambiamenti negativi che, tuttavia, in determinate circostanze possono anche trasformare una criticità in un fattore di opportunità.
Entrando nel concreto, sia la pandemia da Covid-19, sia la guerra in Ucraina hanno colto alla sprovvista i media, nonostante l’offensiva russa di certo non rappresenti un evento del tutto imprevisto e imprevedibile, posto che la questione Donbass aveva cominciato a manifestarsi nella sua drammaticità già dal 2014, anche se senza che tale notizia avesse pieno diritto di cittadinanza nell’offerta mediale e news mediale, fatte salve alcune eccezioni. In entrambe le situazioni abbiamo registrato le enormi difficoltà dei due accadimenti a trovare una giusta collocazione negli immaginari collettivi. Chi del resto avrebbe mai pensato che nel 2020 l’umanità intera fosse minacciata da un virus e che un conflitto potesse scoppiare nel cuore dell’Europa, evocando lo spettro dell’esplosione della terza guerra mondiale, come affermato il 25 aprile dal ministro degli esteri russo Lavrov? La distanza tra le aspettative collettive, almeno quelle occidentali, e i fatti ai quali qui ci si riferisce rappresenta una cartina di tornasole interessante per cogliere il grado di impreparazione e persino l’iniziale senso di impotenza dei cittadini, ma sotto certi versi anche di chi ha responsabilità degli equilibri geopolitici. Da questo punto di vista le affinità perdono leggermente di consistenza, aprendo la strada alle difformità tra i due eventi.
Quanto alle differenze, dunque, ne individuerei almeno tre. La prima: la pandemia ha sviluppato forme specifiche d’interlocuzione con l’ambiente reale, più che con l’ambiente simbolico. Il Covid ha comportato, infatti, conseguenze misurabili quotidianamente da ciascuno di noi, costringendoci a fare i conti a livello esperienziale con limitazioni alla libertà personale, con i dispositivi di protezione, con scelte obbligate in ordine alla prossemica relazionale, con il distanziamento fisico inter-personale più che con un vero e proprio distanziamento sociale. Fanno eccezione rispetto a questo scenario le questioni economiche, atteso che anche la crisi ucraina comincia a generare effetti riscontrabili pure nell’ambiente reale, oltre che naturalmente in quello simbolico, come dimostrano il prezzo dell’energia e gli effetti dell’inflazione. La seconda differenza: la guerra ha comportato in modo quasi automatico una valutazione in ordine alle responsabilità politiche e persino etiche, generando forme di narrazione polarizzate tra aggrediti e aggressori, tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra utile e inutile. La terza e ultima differenza si innesca paradossalmente su un’analogia rappresentata dalla forza di cannibalizzazione dei palinsesti televisivi e radiofonici, dalla omologazione degli spazi editoriali della stampa di massa quotidiana e periodica e delle testate on line, dal ricorso più ampio nella narrazione della guerra ai significanti non verbali (immagini e suoni) rispetto a quelli verbali (parole scritte e parlate). Il tutto nel nome, appunto, dell’emergenza.
Diversi osservatori hanno rilevato come all’infodemia derivante dalla crisi indotta dal COVID 19 se ne sia sostituita un’altra dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Come evitare il rischio che un eccesso di informazioni alla fine generi una crisi di rigetto e fiducia nei cittadini verso i media?
“Infodemia” è una parola chiave del nostro tempo. Ha cominciato a circolare nel discorso pubblico in occasione degli iniziali lockdown dovuti al Covid-19 anche su impulso dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma in realtà la sua prima utilizzazione è datata qualche anno prima e si deve a David J. Rothkopf, che nel 2003 sul Washington Post fece riferimento all’epidemia da informazione, ovvero al sovraccarico di informazioni. Condizione che indebolisce, proprio per il primato della dimensione quantitativa rispetto a quella qualitativa, la capacità di discernimento e di selezione del pubblico in nome della maggiore credibilità ed attendibilità dei contenuti portati all’attenzione delle masse e al tempo stesso dei singoli, secondo dinamiche che sanno essere verticali e orizzontali.
Gli effetti dell’infodemia sono sostanzialmente due: rafforzamento della labilità del confine esistente tra verità e falsità o tra verità e verosimiglianza; indebolimento della capacità d’individuazione della paternità delle informazioni in base al principio che ciò che conta di più è che un determinato messaggio colpisca l’attenzione del pubblico e non che esso sia stato o sia generato da un soggetto anziché da un altro. Per evitare questi rischi, peraltro connaturati alle caratteristiche del nuovo ecosistema comunicativo nel quale convivono vecchi e nuovi media, piattaforme social e di instant messaging, occorre agire su un doppio versante.
Anzitutto occorre agire sul versante della maggiore responsabilizzazione dei proprietari e dei gestori dei media owned e dei media paid per i contenuti pubblicati, molti dei quali immaginati fin dall’inizio per sfruttare le logiche della viralità. Da questo punto di vista l’inasprimento di sanzioni penali e di multe, unitamente ad una più strutturata ed efficiente azione di debunking e fact checking, può fare la differenza. E poi occorre investire in programmi di sensibilizzazione degli utenti per evitare che essi ricorrano a quello che Daniel Kahneman chiamerebbe il “pensiero veloce” fondato su scelte irrazionali, sull’intuito, sulla rinuncia alla logica. Aggiungo che devono essere fatti ancora significativi passi in avanti in direzione della diffusione delle competenze digitali. Il tema si pone con urgenza, specie se è nostra ambizione generare nel tessuto sociale una vera e propria cultura del digitale.
Sia il Covid-19, sia la guerra in Ucraina hanno reso queste considerazioni ancora più evidenti, visto che tutti i giorni occorre misurarsi con notevoli quantità di fake news. Un fenomeno non nuovo in verità, ma di certo reso ancor più pericoloso dalla diffusione dei contenuti informativi o pseudo-informativi sulle piattaforme social da e con soggetti che sono al tempo stesso produttori e consumatori dei contenuti medesimi. Per questo è stato indispensabile (qui siamo ad un’altra analogia tra i due eventi) il ricorso agli esperti: prima virologi ed epidemiologi, poi studiosi di geopolitica e di strategie militare.
Tengo a sottolineare che tutto ciò si inserisce nel contesto più ampio dell’information disorder, per usare una formula adoperata dal Consiglio europeo. Un’istituzione che ha previsto sostanzialmente due dimensioni applicative. La prima è quella della disinformation, ovvero la volontà di costruire notizie false per orientare comportamenti collettivi, dopo aver modificato idee e opinioni individuali. La seconda è quella della misinformation, ovvero la diffusione involontaria di notizie false che si propagano in modo virale, indipendentemente dall’azione del produttore dei contenuti. È evidente che il discrimine tra la prima e la seconda tipologia risieda nella intenzionalità o meno dell’agire comunicativo, quando e se esso è finalizzato alla proposizione nella sfera pubblica mediata, come la definisce Thompson, di elementi in grado di alterare la dinamica democratica o il funzionamento del mercato. Il tema vale a maggior ragione nel caso di un conflitto.
Attenzione, però, perché la non intenzionalità, almeno nella produzione dell’effetto finale di manipolazione o di parziale modificazione della realtà rappresentata e rappresentabile, è la chiave per leggere anche la distorsione involontaria nei processi di newsmaking ad opera dei media mainstream. Distorsione che si verifica in ordine alla raccolta delle informazioni, ai valori e ai criteri di selezione del materiale notiziabile, alle modalità di gerarchizzazione e trattamento delle notizie, alle logiche di tematizzazione attraverso le quali si decontestualizzano e si ricontestualizzano gli accadimenti che potrebbero essere trasformati dai newsmaker in vero e proprio contenuto editoriale.
Nella letteratura scientifica una possibile risposta a questo problema, in grado di concretizzarsi anche nell’enorme difficoltà a gestire l’effetto di framing e l’uso degli stereotipi, è stata individuata con l’innalzamento del livello di competenza degli attori dell’intero ecosistema mediale, secondo una precisa classificazione ruotante intorno ai concetti di competenza tematica, relazionale, tecnica, espressiva, deontologica, ma anche sfruttando la dicotomia proposta in letteratura da Max Weber, il quale ha distinto tra obiettività “orientata al valore” e obiettività “orientata allo scopo”. In questo secondo caso si fa riferimento all’individuazione di precise regole definite dagli studiosi di sociologia della comunicazione come “routine burocratiche produttive”. Ma qui entriamo nel vivo di questioni che hanno a che fare con le modalità di funzionamento del sistema dell’informazione.
La pandemia e la guerra hanno infatti messo il sistema dei media, tradizionali e non, di fronte ad una sfida forse mai affrontata prima con grandi rischi, ma anche opportunità di cambiamento. In che modo questi due eventi stanno cambiando il modo di fare informazione?
La sfida alla quale lei fa riferimento in verità si palesa da oltre un decennio. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno solo reso evidente a tutti quanto già lo era agli studiosi dei media. Rischi e opportunità di cambiamento sono due facce della stessa medaglia. Il nuovo ecosistema comunicativo si fonda sulla convivenza di logiche vecchie e nuove, di strategie di mass communication e di personal communication.
Il sociologo Castells ha elaborato a tal fine una formula semantica, quasi ossimorica: mass self communication. Trattasi di un ibrido tra la comunicazione “one to many” del secolo scorso (che ancora sopravvive, considerando il tasso di penetrazione del mezzo televisivo e il successo di quello radiofonico) e quella più social e generata dalla rete: “one to one”, “many to many”, “many to one”. È come se tutti volessero parlare a tutti e a ciascuno contemporaneamente, ma su tutti gli argomenti. L’attenzione dei riceventi dei processi comunicativi è diventata la vera risorsa. Per catturare l’attenzione e soprattutto per stabilizzarla nel tempo, si lavora su forme d’interlocuzione con la sfera emozionale del pubblico sempre più esplicite.
In questo contesto da un lato è più facile raggiungere e conversare con fette di utenti mirate e al tempo stesso presenti su larga scala, dall’altro ogni strumento diventa lecito, pur di favorire la creazione di engagement. È un po’ la natura stessa del web, specie del web 2.0, a creare queste condizioni miste, fatte di minacce e opportunità. Le minacce sono quelle legate all’accertamento della verità. Le opportunità sono quelle determinate dall’implementazione del livello di partecipazione. Una spia di questa inversione, se non di confusione di ruoli, tra coloro che operano nel settore della comunicazione e coloro che operano nel settore dell’informazione, può essere rappresentata da quel gioco linguistico che proposi alcuni anni fa, quando parlai per la prima volta di separazione tra le parole “informazione” e “giornalismo”, ipotizzando una “informazione senza giornalismo” e un “giornalismo senza informazione. Nel primo caso si fa riferimento al fatto che una parte del pubblico percepisce come informazione anche ciò che non è generato dal giornalismo in quanto organizzazione professionale fondata, come ricordavo prima, su un insieme consolidato di competenze. Nel secondo caso si fa riferimento all’inseguimento di quello che Schudson avrebbe chiamato “market model”, ovvero modello incentrato sul primato del mercato dove, nella selezione del materiale notiziabile, ciò che conta è l’inseguimento del big news values dello human interest, più che la ricerca dell’equilibrio tra interesse e importanza.
Molte di queste logiche sono state e sono alla base dei molteplici tentativi di seduzione del pubblico, più che dell’ attività di informazione di telespettatori, radioascoltatori, lettori, navigatori online. In cosa si è tradotto tutto questo nella fase pandemica? Nell’affiancamento di notizie non sempre verificate e verificabili a notizie frutto di un lavoro accurato di accertamento e ricostruzione delle informazioni. Un lavoro portato avanti anche grazie alla collaborazione di esperti e in ossequio al principio dell’urgenza dell’alfabetizzazione scientifica dei media e dell’alfabetizzazione mediatica della scienza.
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il tema qui affrontato ha registrato e continua a registrare un punto di ricaduta nella gestione dei tentativi di propaganda da parte dei due contendenti, con evidenze più marcate e certamente più nocive da parte russa, a partire dall’obbligo di non usare nella narrativa pubblica la parola “guerra”, ma solo l’espressione “operazione militare speciale”. L’alto tasso di mediatizzazione del conflitto in Ucraina è un’evidenza empirica.
Ogni giorno abbiamo prove di questa tendenza. Il fronte ucraino è super rodato e sta dimostrando enormi abilità comunicative, come dimostrano alcuni esempi.
Il primo è quello della capacità di far emergere l’orrore delle fosse comuni prima a Bucha e poi nei dintorni di Mariupol.
Il secondo è quello della sistematicità degli interventi del Presidente Zelensky, artefice il giorno della vigilia della Pasqua ortodossa di una conferenza stampa nella metropolitana di Kiev con circa duecento giornalisti e con una regia degna dei grandi eventi televisivi.
Il terzo è quello di uno storytelling in grado di far leva su concetti semplici e diretti, gestiti in coerenza dei due obiettivi principali: la logica di “Davide contro Golia”, che con un’espressione anglosassone potremmo anche definire “sindrome da underdog” ovvero da “cane bastonato” (logica che suscita quasi sempre consenso e vicinanza); la call to action dell’intera comunità internazionale.
Marshall McLuhan affermava che “Le società sono sempre state modellate più dal tipo dei media con cui gli uomini comunicano che dal contenuto della comunicazione.” Qual è la sua visione in merito a questo processo di trasformazione nell’era dei social media?
Per rispondere a questa domanda occorre far riferimento anzitutto ad uno dei paradigmi della Scuola di Toronto, artefice del teorema del determinismo tecnologico. Secondo questo teorema, la società postmoderna è quel tipo di società in cui la tecnologia non si limita ad accompagnare il cambiamento, ma lo determina in tutte le sue forme e modalità. Il sociologo van Dijck ha giustamente parlato di platform society per enfatizzare la capacità di condizionamento dei comportamenti più diffusi da parte della collettività, in ordine a pensieri, azioni, intenzioni veicolati dalle piattaforme online in una logica di iper-connessione, che di per sé rappresenta un’alternativa d’uso sia nella dimensione privata, sia in quella pubblica.
Temi come l’equità, l’accessibilità, il controllo democratico, l’accountability, l’interazione tra società, mercati e governi sono la riprova che il problema non è certo quello della natura in sé dei singoli mezzi, quanto del loro uso effettivo, delle strategie che sovrintendono alla loro adottabilità nei processi di creazione e gestione del valore percepito. Quello che sto qui proponendo è un approccio laico, non ideologico al tema della tecnologia. Un approccio che prevede esperienze di consapevolezza diffusa e condivisioni di interventi su ampia scala e di natura interdisciplinare, con l’intento di evitare che i pericoli siano più evidenti dei vantaggi. Pensiamo al tema della guerra. Quante immagini abbiamo ricevuto dai cittadini ucraini grazie all’uso delle piattaforme. Cittadini che, dunque, si sono trasformati in citizen journalist.
Dopo Covid e guerra la parola del momento è forse PNRR, un’opportunità da molti definita irripetibile per il nostro Paese. Cosa può fare il mondo dell’informazione per aiutare l’Italia a vincere questa sfida?
È apprezzabile quello che sta facendo il Governo Draghi in ordine al PNRR, anche dal punto di visto della comunicazione. È un lavoro che va portato avanti con determinazione per evitare che questa opportunità enorme di riforma del nostro Paese resti una priorità solo per pochi.
Occorre istituire figure ad hoc dal punto di vista comunicativo sul e del Next generation Eu per spiegare anzitutto la portata, anche dal punto di vista culturale, di un acronimo come il PNRR, che contiene termini impegnativi come “ripresa” e “resilienza”. La prima è una parola che va oltre il piano più squisitamente economico, facendo riferimento a concetti come quelli legati alla grande rivoluzione della sostenibilità: economica e sociale. In ordine alla strutturazione del messaggio, volendo seguire lo schema di Lasswell, occorre lavorare sul racconto della natura dei diversi progetti, ma anche dell’accesso ai fondi e della produzione di effetti multidisciplinari sul Paese, a partire dalla creazione di “consapevolezza”. Concetto che non si limita alla sola conoscenza, e “fiducia”.
Come diceva Giovanni Paolo II, infatti, la fiducia non si ottiene con la forza o con le sole dichiarazioni, ma bisogna meritarsela con gesti e fatti concreti. Infine i target. Sono tre quelli da raggiungere: pubblica amministrazione (che diventa prosumer, poiché è al tempo stesso producer e consumer), imprese; cittadini. E’ questo, a mio avviso, il modo più efficace per tenere in equilibrio il valore reale e il valore percepito del PNRR.
Emidio Piccione, Giornalista