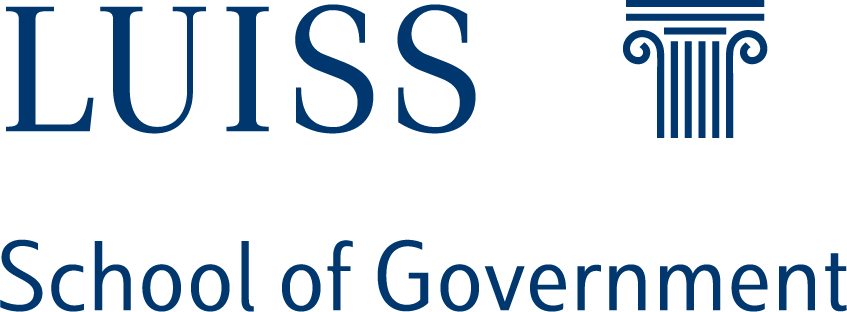Musei e Influencer Marketing

di Nausica Colozzo
La cultura si fa (sui) social, oggi più che mai. Complici la pandemia e il calo del turismo estero, i musei e le istituzioni hanno dovuto fare i conti con sale colme di opere, ma vuote di pubblico. Si è reso necessario, dunque, il rinnovamento di una strategia di brand awareness, capace di cambiare in termini strategici la comunicazione social, con l’intento di consentire la creazione di contenuti qualitativi, ma anche di intrattenere un dialogo costante e affidabile con il proprio pubblico di riferimento.
L’influencer marketing si pone al servizio dell’arte -e viceversa- in una dialettica serrata tra il nuovo e il vintage, tra il sacro e il profano, tra identità e reputazione, tra giusto e sbagliato. La disamina della questione, tuttavia, andrebbe svolta in maniera totalmente scevra da giudizi e sensibilità personali, come un mero fatto di marketing: un brand (un museo, in questo caso) individua gli influencer pertinenti al proprio patrimonio valoriale e idealizza un progetto editoriale e di storytelling che risulti credibile e impattante per un determinato target. I vari influencer servono come collante per la community, che ormai ripone fiducia in loro e attiva comportamenti di imitatio ed emulatio in un rapporto quasi orizzontale tra influencer e pubblico.
La comunicazione culturale e i musei non potevano restare a guardare anche stavolta, arroccati su posizioni di antico prestigio. Così gli Uffizi e i Musei Vaticani hanno aperto le porte ai Ferragnez, il Museo Archeologico di Napoli ha scelto di farsi rappresentare dal gruppo satirico dei partenopei The Jackal, la Card Musei Bologna ha prediletto la comunicazione ironica di Luis Sal, Mahmood ha sfruttato la bellezza del Museo Egizio di Torino come location per il suo clip musicale e l’influencer Cristina Fogazzi, alias l’Estetista Cinica, ha organizzato i tour di musei meno sconosciuti come ritrovo per le sue fagiane (nome con cui indica le proprie followers).
Siamo di fronte a una rivoluzione comunicativa tout court nel senso copernicano del termine: rivoluzione come movimento, slittamento di mezzi, strumenti, anche di target che può fruire del patrimonio culturale. Per sopravvivere, oggi, i musei hanno bisogno di reinventarsi o meglio di riposizionarsi. La digitalizzazione e l’incremento dei social media deve rappresentare un medium e una risorsa anche per la comunicazione istituzionale, ma deve servire anche per progetti di educazione alla cultura e all’arte dei più giovani. Andare ad una mostra deve essere vissuta un’opportunità al pari dell’andare ad un concerto, così come la visita alle Scuderie del Quirinale può diventare un’esperienza cool.
Lontano da un certo snobismo di chi vuole relegare la cultura a settore di nicchia, tale rivoluzione comunicativa si traduce in un cambio di paradigma culturale. Parliamo di numeri: l’operazione di marketing dei Musei Vaticani, ad esempio, ha avuto successo: nel weekend del 30-31 maggio 2020, complici le riaperture dopo il lockdown, le prenotazioni sono state registrate in crescita, con un’età dei visitatori compresa tra i 15 e i 45 anni. L’account Instagram Vatican Museum può contare su un seguito di 183mila follower (100mila se si tiene conto del 30-31 maggio 2020) e i video su Tik Tok di Chiara Ferragni e consorte furono trend topic su Google per diversi giorni.
Feuerbach nel 1800 diceva ‘noi siamo quello che mangiamo’, nel 2021 forse direbbe che ‘noi siamo quello che vediamo e quello che comunichiamo’. Comunicare la cultura deve diventare un’urgenza sociale. Il binomio tra i social e la cultura si rivolge a una generazione di giovani (la fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni), che necessitano di nuovi e più coinvolgenti linguaggi, a metà tra creatività fotografica e sagacia narrativa. Lungi dall’essere esperti del settore, gli influencer vengono scelti per il tipo di engagement che producono, per la capacità di conversione verso gli stakeholder, quindi per la possibilità di convincere potenzialmente i propri follower a compiere un’azione, su base fiduciaria e in termini di credibilità.
I puristi dell’arte si indignano per un’operazione di marketing così raffinata, nella convinzione che il valore artistico di istituzioni e musei non possa essere svilito dalle logiche di blogger, influencer e celebrities, nella presunzione cristallizzata che il marketing sia altro dalla cultura, dalla sociologia, dall’educazione all’estetica. Si opera insomma una netta distinzione tra otium e negotium, additando i neofiti dei musei e degli eventi culturali come ricettori passivi, fagocitati dalla reputazione dell’influencer di turno e pronti a pubblicare la prossima Instagram story.
Ma piaccia o non piaccia, i musei non sono luoghi sacri al servizio di un’oligarchia, ma brand il cui patrimonio valoriale deve essere comunicato nel modo migliore ed efficace per un ritorno in termini di engagment e di brand identity. Non si tratta del machiavellico ‘il fine giustifica i mezzi’, bensì di adeguare la comunicazione istituzionale ai nuovi canali, alle nuove forme di advertising e ai nuovi linguaggi. Una doppia educazione o rieducazione, dunque: da un lato addomesticare un nuovo e più giovane pubblico all’arte, per mezzo di strumenti che sentano propri e che fruiscono abitualmente; dall’altro abituare i veterani della cultura che il patrimonio intellettuale oggi può sfruttare una contaminazione di forme e misure, un’ibridazione tra media tradizionali e nuovi strumenti di comunicazione, che passano attraverso l’esperienziale, il selfie nella Cappella Sistina, la visita su Skype delle meraviglie del Louvre.
L’arte si fa social e si fa sui social! D’altronde, l’annus horribilis dovrebbe averci insegnato quanto la tecnologia funga da surrogato indispensabile all’uomo e quanto una comunicazione istituzionale consapevole e coerente sia necessaria per un apprendimento partecipativo. Tutto ciò, nella convinzione che la linea tra online e offline sia solo un velo di Maya.
(Foto di copertina: Instagram/Fedez)