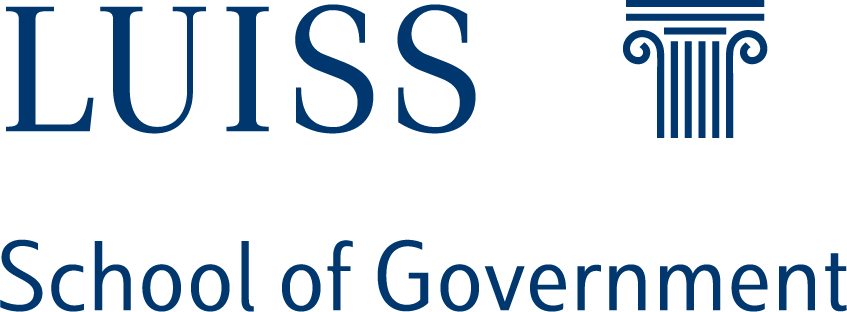“Patria Y Vida” o “Patria Y Muerte”? Un’analisi comparata delle proteste a Cuba

di Maria Elena Cavallaro
Decine di arresti di cittadini cubani, il blocco di internet, le restrizioni e perfino gli attacchi alla (poca) stampa internazionale presente sull’isola, da ultimo qualche concessione retorica ai manifestanti: così il regime cubano, dall’ottobre 2019 presieduto da Miguel Díaz-Canel, sta tentando di ridimensionare moti di piazza che, per diffusione e intensità, non si vedevano sull’isola da anni, almeno dal 1994. Di seguito si tenterà di tracciare una prima comparazione tra le manifestazioni di oggi e quelle di 27 anni fa.
Economia, libertà e pandemia. Tra gli elementi di continuità fra i due episodi di mobilitazione del dissenso, sicuramente, c’è una situazione economica critica a Cuba. Nel 1994 i manifestanti che sfilarono per le principali strade dell’Havana chiedevano libertà, ma il motivo principale di quelle proteste furono i sempre più ricorrenti black-out energetici e le difficoltà di approvvigionamento per alcuni beni materiali piuttosto basici. Si trattò di fenomeni direttamente collegati alla fine della Guerra Fredda e all’eclissarsi definitivo del sostegno economico che fino ad allora era arrivato dall’Unione Sovietica. Di nuovo, 27 anni dopo, la crisi economica può essere considerata anche oggi la “miccia” che ha dato fuoco alle polveri della contestazione. Una crisi economica profonda, visto che il Pil cubano è calato ufficialmente dell’11% nel 2020, figlia anche della pandemia che ha drasticamente ridotto gli introiti provenienti dal turismo internazionale, aggravata da una situazione sanitaria compromessa per la stessa diffusione del virus Sars-Cov-2 e da un irrigidirsi dell’atteggiamento americano dopo i tentativi di distensione dell’era Obama. Tuttavia, se nel 1994 le richieste generiche di “libertà” si confondevano sempre con l’appello a una maggiore e più efficace “assistenza” da parte del regime cubano, stavolta il superamento dell’attuale regime autoritario sembra un obiettivo esplicito dei manifestanti. Uno degli slogan-simbolo delle manifestazioni in corso è, non a caso, “Patria Y Vida”, mutuato da una canzone rap scritta da un gruppo di famosi artisti locali, un esplicito e provocatorio capovolgimento dello slogan rivoluzionario “Patria Y Muerte”. Nel testo della canzone, così come negli slogan di piazza, si evoca il tramonto di un regime considerato come distante dalla vita quotidiana, incapace ormai anche di instillare il terrore nei cittadini, si parla di un “inganno finito”. Oggi come nel 1994, infine, i manifestanti sono bollati come agenti contro-rivoluzionari prezzolati dall’estero e dalle potenze nemiche; un refrain comune ai regimi marxisti, per quanto infondato considerati i numeri in campo (oggi i manifestanti sono anche fuori dall’Havana, a differenza che nel 1994) e il carattere di spontaneità delle manifestazioni in corso. D’altronde proprio lo spontaneismo delle proteste rende difficoltosa, nel breve termine, la formazione di una classe dirigente alternativa a quella comunista, che si possa essere formata le ossa negli anni all’interno di partiti o movimenti di opposizione davvero strutturati.
Il fattore leadership. Per mettere fine alle manifestazioni di piazza del 1994 fu decisivo, oltre alla brutale repressione, l’intervento diretto di Fidel Castro. Egli fece allora direttamente appello allo spirito della rivoluzione del 1959 da lui rappresentato e incarnato. Raúl Castro, dal 2008 al 2018, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’isola, succedendo al fratello: da lui certo non ereditò il carisma, ma con lui condivideva una forte legittimazione rivoluzionaria. Miguel Díaz-Canel, l’attuale presidente cubano che è succeduto a Raúl, manca sia di un carisma straordinario sia di legittimazione rivoluzionaria: è nato nel 1960, un anno dopo la rivoluzione, appartiene dunque a una diversa generazione che non fu protagonista attiva di quel momento fondativo. La difficoltà dell’attuale presidente e segretario del Partito comunista cubano emerge anche dalle formule retoriche ambivalenti con cui il Partito, nell’ultimo congresso dello scorso aprile, si è dato come obiettivo quello di “riformare la rivoluzione”.
Il contesto internazionale. Negli scorsi giorni i Paesi dell’America latina non hanno risparmiato critiche alla repressione in corso a Cuba. La crescente solitudine diplomatica dell’Havana, anche in un’area in cui è stata a lungo considerata con simpatia in quanto bastione (simbolico) di fronte all’imperialismo americano, è una novità rispetto agli anni passati. Ancora una volta, il cambio di leadership e l’assenza del “simbolo” Fidel Castro (1926-2016) contribuiscono a spiegare questa mancata mobilitazione internazionale. Inoltre le modalità devastanti con cui la pandemia sta colpendo tutta l’America latina, così come l’endemica instabilità politica nell’ex alleato Venezuela, fanno sì che la situazione all’Havana non costituisca una priorità per le classi dirigenti degli altri Paesi. Le aggressioni alla stampa internazionale, con gli annessi danni d’immagine, fanno il resto.
Come stanno reagendo invece le potenze occidentali? Dall’Unione europea, per il momento, si registra una dichiarazione di Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, a favore del diritto di manifestare e di esprimere opinioni da parte dei Cubani. I singoli Stati membri sembrano più attendisti, in particolare la Spagna – per ragioni politiche interne e di conflittualità nel governo di centrosinistra – che invece tradizionalmente era stata più attiva sul dossier cubano. Quanto agli Stati Uniti, fino a questo momento il presidente democratico, Joe Biden, aveva relegato le relazioni con Cuba ai margini della sua agenda di politica estera, centrata piuttosto sul confronto nell’Indo-Pacifico con la Cina e in Europa orientale e sul web con la Russia. Al netto di alcune dichiarazioni di sostegno del diritto di manifestare, Biden finora ha scelto di non scegliere, non ha sconfessato né le aperture del Presidente Barack Obama né l’irrigidimento deciso dal suo predecessore repubblicano Donald Trump (per esempio col blocco delle rimesse degli emigranti).
La variabile emigrazione. Un ultimo aspetto che merita qualche riflessione è il ruolo dei movimenti di popolazione in questa crisi. La repressione del dissenso non mancava nemmeno negli anni di massimo fulgore del regime castrista. Tuttavia tale repressione fu accompagnata da fasi storiche in cui Castro favoriva, strumentalmente, la fuoriuscita dall’isola di decine di migliaia di cittadini, a mo’ di valvola di decompressione per le tensioni domestiche. Accadde nel 1965, quando Castro aprì il porto di Camaiorca a quanti desideravano lasciare l’isola, poi di nuovo nel 1980 con la crisi dei marielitos. In entrambe quelle occasioni gli Stati Uniti furono particolarmente generosi nell’accogliere gli esuli cubani, anche in chiave anti-comunista. Terminata la Guerra Fredda, però, negli Stati Uniti il tema dell’immigrazione ha cambiato valenza politica domestica, dagli anni 90 e con la presidenza di Bill Clinton si sono dunque affermate politiche più restrittive – respingimenti o detenzione – anche nei confronti dei balseros, vale a dire i Cubani che fuggivano su imbarcazioni di fortuna, mettendo indirettamente fine a quel meccanismo che contribuiva ad allentare alcune tensioni sull’isola.