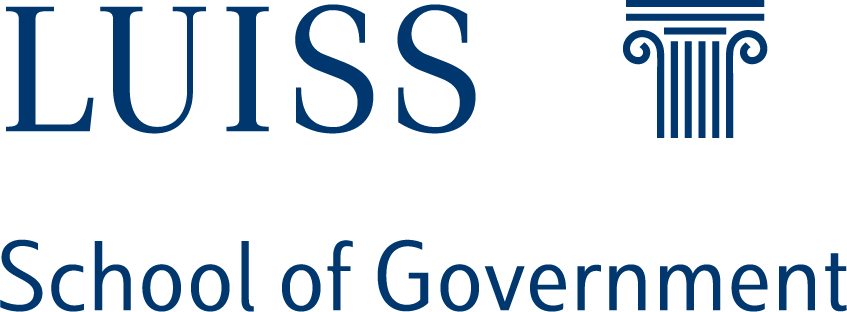Sulle relazioni Unione europea-Cina, un accordo sugli investimenti non fa primavera

di Arnaud Leconte
Alla vigilia dell’arrivo a Bruxelles del nuovo Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, l’Unione europea ha annunciato sanzioni contro alcuni individui e autorità cinesi coinvolti nella repressione della minoranza islamica degli Uiguri. È la prima volta che accade dal 1989, cioè dai disordini di Piazza Tien An Men. Sanzioni simili sono state comminate, poche ore dopo e sempre per dichiarata violazione dei diritti umani, anche da Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Da qui la rappresaglia del ministero degli Esteri di Pechino che ha imposto il divieto di ingresso nella Repubblica popolare cinese a dieci cittadini (tra cui alcuni europarlamentari e analisti indipendenti) e a quattro entità dell’Unione europea. La risposta cinese ha suscitato una dura reazione dal Parlamento europeo, al punto che alcuni gruppi politici ora condizionano esplicitamente la ratifica del recente accordo bilaterale Ue-Cina sugli investimenti (CAI, Comprehensive Agreement on Investment) al ritiro delle sanzioni che colpiscono gli europarlamentari. Ecco dunque un’inaspettata tegola diplomatica che cade e colpisce un accordo già molto discusso. Vediamo perché.
Dopo anni di trattative diplomatiche, Unione europea e Cina alla fine del 2020 hanno siglato un’intesa di principio sul Comprehensive Agreement on Investment, o CAI. Secondo la Commissione europea, l’obiettivo di questo accordo è quello “di fornire agli investitori di entrambe le parti un accesso prevedibile e di lungo termine ai mercati europeo e cinese, di proteggere gli investitori e i loro investimenti”. L’accordo si fonda su tre pilastri: accesso al mercato, “livellamento del campo di gioco” per gli operatori economici (in particolare in materia di trasferimenti tecnologici e imprese di Stato), sviluppo sostenibile. Anche gli osservatori più critici hanno ammesso che “l’accordo in teoria offre all’Europa maggiori opportunità in Cina per quanto riguarda automobili, cloud computing, servizi finanziari, sanità e telecomunicazioni” (Wall Street Journal, 10 gennaio 2021). Solo il tempo, e il tipo di enforcement applicato, potranno dire se – grazie al CAI – l’Unione europea sarà riuscita finalmente a scegliere una propria postura geopolitica rispetto a Pechino, nel mezzo della rivalità sistemica tra Cina e Stati Uniti.
La tempistica dell’accordo CAI per ora suscita qualche dubbio sulla posizione europea nei confronti della Cina. I negoziati per questo accordo bilaterale per gli investimenti tra Bruxelles e Pechino sono iniziati nel novembre 2013. Allora il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, si impegnavano a costruire un “nuovo modello” di relazioni tra le due superpotenze, e Bruxelles in qualche modo si sentiva tagliata fuori. Un accordo con Pechino era dunque ritenuto un fattore di bilanciamento, anche se poi i negoziati hanno richiesto più tempo di quanto non ci si attendesse. Nel frattempo, però, l’Amministrazione americana, durante la Presidenza di Donald Trump, ha cambiato atteggiamento nei confronti della Cina e ha abbandonato i negoziati dell’epoca obamiana. L’Ue ha invece continuato le sue trattative, e non senza motivo. Anche se gli investimenti diretti esteri cinesi in Europa sono diminuiti negli ultimi anni, in linea tra l’altro con la diminuzione degli investimenti diretti esteri in uscita dalla Repubblica popolare che si registra dal 2016, questo tipo di investimenti ammontava comunque a 12 miliardi di euro nel 2019, abbastanza perché Pechino cercasse di ottenere qualche garanzia e protezione in più. Di conseguenza, negli ultimi tempi, l’obiettivo dell’intesa è cambiato: da fattore di bilanciamento all’epoca di Obama, esso per l’Ue è diventato un passepartout per evitare di rimanere stritolati nelle crescenti frizioni tra la Cina e gli Stati Uniti di Trump. Sempre a proposito della tempistica dell’accordo CAI, occorre notare che esso è stato raggiunto alla fine del periodo di Presidenza tedesca del Consiglio Ue. Berlino è sembrata volersi affrettare a siglare il CAI e Pechino ha risposto positivamente a questo sforzo negli ultimi mesi, per esempio mobilitando i suoi diplomatici di rango più alto. Alla fine, il Presidente Xi Jinping in persona ha partecipato alla cerimonia della firma, volendo apparire al fianco della cancelliera tedesca Angela Merkel, anche nella prospettiva di conquistare un accesso privilegiato al mercato tedesco e in particolare alla tecnologica tedesca.
Il ruolo preminente giocato dalla Germania nella firma del CAI fa sorgere dei dubbi sull’esistenza di una posizione univoca e coerente dell’Europa nei confronti della Cina. Gli sforzi tedeschi di accelerare la firma dell’intesa hanno avuto successo, ma allo stesso tempo hanno attirato le critiche di altri Paesi membri dell’Ue, confermando ancora una volta che una posizione comune rispetto a Pechino è lungi dall’essere trovata ed è minata dalle diverse sensibilità dei 27 Stati. Fino ad oggi, probabilmente, la Commissione europea avrebbe prediletto una posizione di neutralità fra Stati Uniti e Cina, mentre gli Stati membri strattonano Bruxelles ora da una parte ora dall’altra. L’Italia è un caso di scuola di questo andamento “a pendolo”: nel 2018 è stata la prima nazione del G7 a firmare il progetto cinese ribattezzato “Via della Seta”, oggi invece col nuovo governo è tra quanti vogliono rinsaldare l’alleanza transatlantica. La posizione dell’Ue nei confronti della Cina rischia di diventare sempre più difficile da sostenere negli anni a venire. L’Amministrazione Biden, infatti, ritiene che la Cina sia “l’unico concorrente potenzialmente in grado di combinare assieme la sua forza economica, diplomatica, militare e tecnologica per incarnare una sfida duratura a un ordine internazionale stabile e aperto”. Di conseguenza Washington eserciterà una pressione crescente sugli alleati europei affinché non “pendano” verso Pechino.
Dal punto di vista economico, una qualche forma di ribilanciamento europeo verso la Cina avrebbe pure un senso. Secondo i dati della Commissione europea, negli ultimi vent’anni gli investimenti dell’Ue in Cina hanno superato quota 140 miliardi di euro. Circa la metà di questo flusso si è indirizzata sul settore manifatturiero, con le aziende automobilistiche tedesche nel ruolo di principali investitrici. Ma oggigiorno l’Ue sta perdendo terreno. Gli investimenti diretti esteri europei negli Stati Uniti sono 15 volte quelli europei in Cina, per esempio. L’export europeo verso la Cina ha un valore pari alla metà dell’export europeo verso gli Stati Uniti, nonostante il Pil cinese abbia raggiunto l’80% del Pil americano. Non solo, gli investimenti dell’Ue verso la Corea del Sud, per esempio, stanno aumentando molto più rapidamente di quelli verso la Cina. In definitiva, è difficile dire che l’Ue stia scommettendo tutto sulla Cina. Sarebbe più preciso dire che alcuni Stati membri dell’Ue, in primis la Germania e l’Olanda, stanno rafforzando le loro relazioni economiche con Pechino più velocemente di quanto non facciano altri Paesi, tentando allo stesso tempo di esercitare una maggiore influenza sulla posizione comune dell’Ue, come dimostrato nel caso del CAI.
Qual è l’interesse cinese a stipulare l’accordo CAI? Sempre negli ultimi vent’anni, i flussi di investimento cinesi verso l’Ue hanno toccato quota 120 miliardi di euro, e sono stati indirizzati soprattutto nelle aree strategiche delle infrastrutture e della tecnologia avanzata. Questo ammontare rappresenta meno del 10% degli investimenti diretti esteri arrivati da Stati Uniti e Canada. In Europa, inoltre, solo 300.000 persone lavorano alle dipendenze di società cinesi, su un totale di 220 milioni di lavoratori. Eppure, secondo Pechino, l’accordo CAI potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’ambito della cosiddetta “strategia della doppia circolazione”. L’espressione, come sintetizzato dal Servizio studi del Parlamento europeo, si riferisce “all’interazione tra la ‘circolazione domestica’ fatta di produzione, distribuzione e consumo (il ciclo economico domestico) e la ‘circolazione internazionale’ (il ciclo economico internazionale), e soprattutto al peso che viene attribuito di volta in volta a ciascuno dei due cicli. La circolazione internazionale è stata l’obiettivo preminente del modello di sviluppo cinese orientato verso l’export fin dai tempi delle riforme e dell’apertura avviate da Deng Xiaoping nel 1978. Spostare l’enfasi del modello di sviluppo cinese verso il mercato domestico, comunque, non è del tutto una novità. È stata una strategia perseguita negli ultimi 15 anni, anche se l’obiettivo è stato raggiunto solo fino a un certo punto. Le descrizioni ufficiali del modello della doppia circolazione come ‘un nuovo sentiero di sviluppo in cui mercati domestico e internazionale possono alimentarsi a vicenda, con il mercato interno nel ruolo di perno’ lasciano intendere che la leadership cinese sia ora intenzionata ad attribuire un’importanza maggiore alla ‘circolazione domestica’ come futuro motore della crescita”. Nelle fasi più acute della pandemia da Covid-19, infatti, gli Stati Uniti hanno avuto la sensazione di essere eccessivamente dipendenti dalla manifattura cinese; anche in Europa si discute con maggiore frequenza dell’idea di accorciare e rendere più sicure le catene globali del valore. La Cina, attraverso l’accordo CAI, tenta così di lanciare una rassicurazione agli investitori, dicendo loro: “Tranquilli, non saremo tagliati fuori dall’emisfero occidentale”.
Cosa manca all’accordo CAI sul fronte degli investimenti, dei servizi e dello sviluppo sostenibile? Come detto all’inizio, la recente intesa Ue-Cina si fonda su tre pilastri, scelti sulla carta con una certa ragionevolezza: accesso al mercato, livellamento del campo di gioco e sviluppo sostenibile. Cosa manca allora all’accordo? Ci concentriamo su almeno tre aspetti. In primo luogo, tutte le principali analisi hanno sottolineato una carenza davvero peculiare per un accordo sugli investimenti: ad oggi infatti non sono previsti meccanismi di tutela degli investimenti, visto che un’intesa su questo punto specifico dev’essere ancora perfezionata. In secondo luogo, considerato che l’economia dell’Ue si fonda principalmente sul comparto dei servizi, col 60% del suo Pil che discende appunto dal settore terziario, dobbiamo ammettere che il settore cinese dei servizi non è ancora del tutto aperto agli investitori internazionali, e l’accordo CAI non interviene per cambiare radicalmente la situazione. Infine l’accordo CAI rientra nella categoria dei cosiddetti “accordi di nuova generazione”, nel senso che l’Ue ha esercitato pressioni per andare oltre i classici accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), così da inserire obiettivi di sviluppo sostenibile tra i punti caratterizzanti dell’intesa. Per questa ragione il terzo pilastro dell’accordo include disposizioni su diritti dei lavoratori, cambiamento climatico e responsabilità sociale d’impresa. Su tali temi, è stato preso un impegno a non abbassare gli standard di leggi e regolamenti, ma il livello preso come riferimento è pur sempre quello delle attuali norme in vigore nelle due aree. Un simile approccio potrebbe funzionare per accordi stipulati con altre democrazie liberali – come avvenuto negli “accordi di nuova generazione” con Canada, Corea del Sud e Giappone – ma è ben al di sotto delle nostre aspettative di democratici quando si tratta con una superpotenza autoritaria come la Cina. Si prenda per esempio il passaggio dell’accordo sul “lavoro forzato”. Pechino si è impegnata a “compiere di propria iniziativa sforzi continui e sostenuti” per ratificare le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro forzato, ma simili convenzioni o si ratificano o non si ratificano, tertium non datur! Assumere una posizione intermedia assomiglia a un mero esercizio retorico.
Cosa succederà adesso? L’accordo bilaterale per gli investimenti tra Unione europea e Cina dovrà essere ratificato dal Parlamento europeo prima di poter entrare in vigore all’inizio del 2022, e non manca una certa opposizione che potrebbe farlo finire su un binario morto. Oltre a tale processo di ratifica, in futuro bisognerà osservare se gli investitori cinesi, al momento allarmati dallo scrutinio sempre più scrupoloso cui sono sottoposti per ragioni di sicurezza, si sentiranno sufficientemente rassicurati dalla nuova intesa per tornare a scommettere sull’Europa quando la pandemia sarà finita. In questa situazione, è importante che gli Stati membri dell’Ue non avviino una sorta di “beauty contest” fra loro per attrarre gli investimenti cinesi, altrimenti Pechino, così come Washington o Mosca, avrà vita facile con la strategia del divide et impera. L’Ue dovrebbe piuttosto cercare di mutare il suo ruolo, diventando “creatrice” di regole generali invece che subirne di nuove e basta. Per fare ciò, dovrebbe cercare di offrire una Terza via strategica innanzitutto al Grande Sud del mondo, un’alternativa all’alleato americano e al suo rivale geopolitico cinese. Una strategia più sofisticata rivolta al Grande Sud potrebbe essere sviluppata attraverso la promozione dell’euro come valuta di riferimento stabile nel commercio internazionale e negli investimenti, in competizione con dollaro e renminbi.