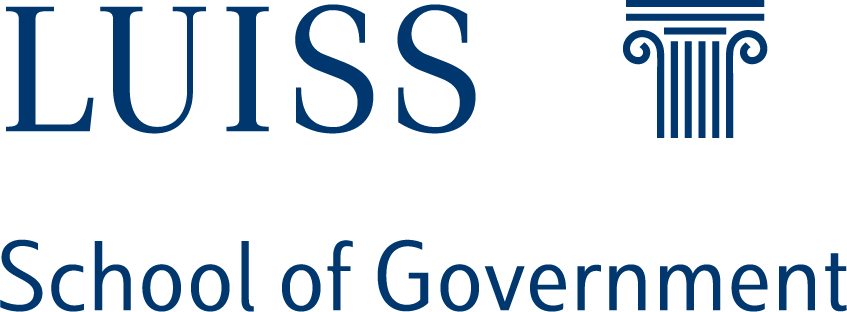Un nuovo compromesso sociale salverà la democrazia?
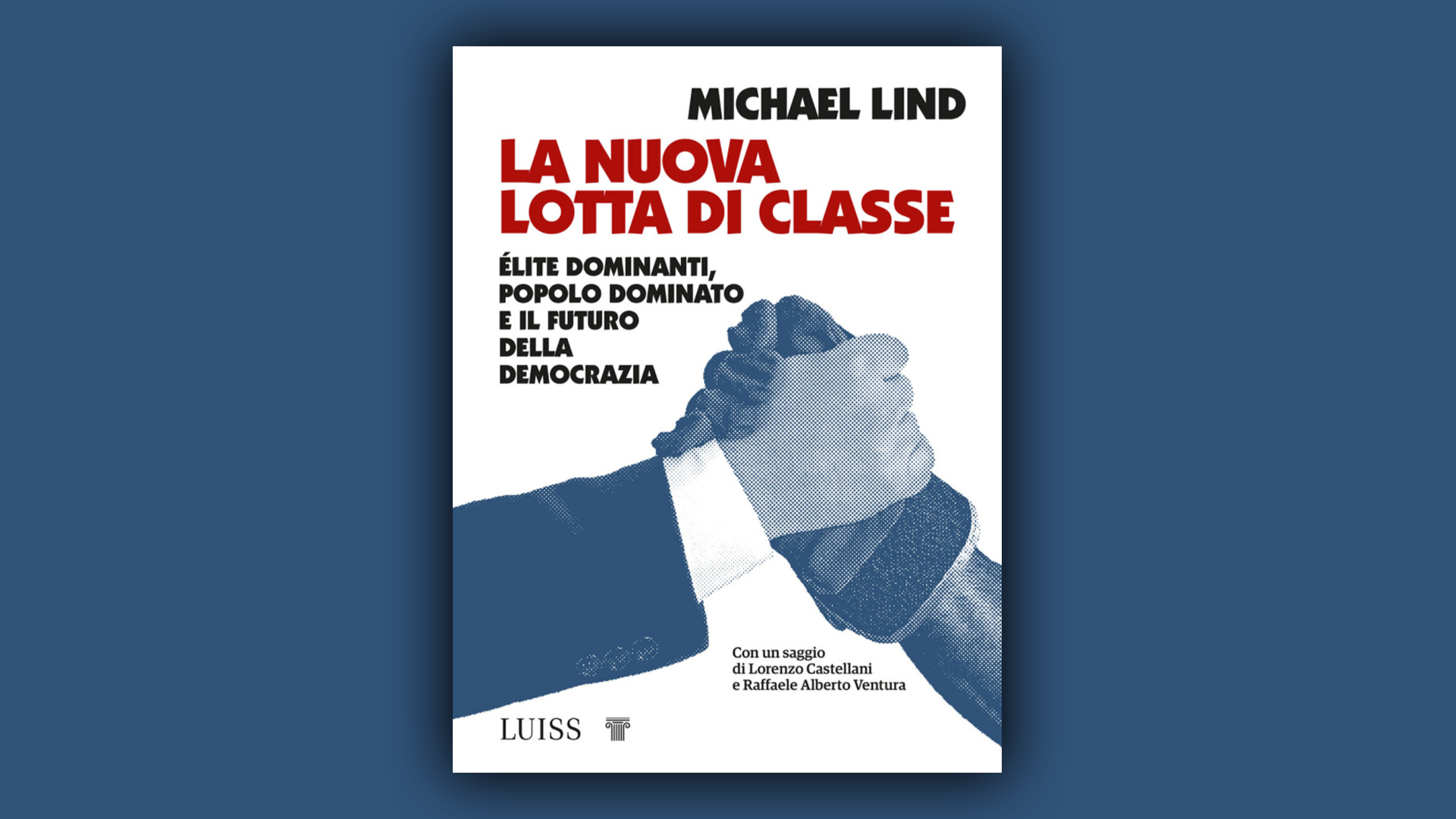
di Leonardo Morlino
Un essai non vuole essere uno scritto scientifico rigoroso, magari con una domanda di ricerca ben definita, uno svolgimento empiricamente preciso, anche se scritto da un accademico noto, come Michael Lind. Con verve polemica e uno stile accattivante e facile da leggere, deve però avere una tesi forte che punti su un tema rilevante, magari anche politicamente. Da questo punto di vista, qual è la tesi di fondo de La nuova lotta di classe. Elite dominanti, popolo dominato e il futuro della democrazia, appena pubblicato dalla Luiss University Press?
Eccola: “Soltanto un nuovo pluralismo democratico che obblighi le élite manageriali a condividere il potere in ambito economico, politico e culturale con la classe dei lavoratori, multirazziale e multireligiosa, potrà porre fine al ciclo di oscillazioni tra tecnocrazia oppressiva e populismo distruttivo” (p. 111). Dunque, una tesi semplice e netta svolta nei diversi capitoli, con la descrizione del pluralismo democratico concentrata soprattutto nell’ottavo e nel nono. L’autore sostiene che l’evoluzione economica, politica e culturale dell’ultima parte del secolo scorso ha evidenziato l’affermazione di una rivoluzione neoliberista dall’alto con l’emergere di una classe manageriale dominante (spec. cap. 4). A questa ha fatto seguito all’inizio di questo secolo una controrivoluzione populista dal basso, dovuta alla rabbia di un’ampia classe operaia esclusa che ha consentito il successo del populismo demagogico e che è il sintomo maggiore di un corpo politico malato (spec. cap. 5).
Come mettere fine a questa nuova lotta di classe dal momento che nel frattempo gli attori intermedi ovvero i partiti e i sindacati, che erano stati così importanti dei decenni successivi al secondo dopoguerra per l’instaurazione delle democrazie pluraliste su entrambe le sponde dell’Atlantico, sono sostanzialmente scomparsi o notevolmente indeboliti dagli sviluppi economici e sociali intervenuti? Se si esclude l’evento catastrofico della vittoria di una classe ovvero della élite manageriale e di una tecnocrazia neoliberale, l’unica soluzione è dare vita a un pluralismo democratico, che integri “i cittadini della classe operaia …nel processo decisionale al governo, nell’economia e nella cultura” (p. 189) e sia caratterizzato da “intese per la spartizione del potere tra le classi e le sottoculture….forme di condivisione del potere, come le istituzioni trilaterali manodopera-imprese-governo che decidono i salari…(oltre a) controlli ed equilibri sociali,…controlli ed equilibri politici…… un consenso duraturo, conquistato a fatica in trattative tra i partiti, le classi e le confessioni religiose…” (p. 166). In breve, il pluralismo democratico configura una concezione normativa della democrazia in cui vi è un ruolo forte e attivo di associazioni che realizzano un’efficace integrazione. La spinta a realizzare questa soluzione convincendo le élite manageriali ad accettarla verrebbe dalla paura derivante da una “rinnovata concorrenza tra le grandi potenze” (p. 186) in modo da sostituire il neoliberismo globalista con uno ‘sviluppismo nazionale’.
La tesi dell’autore induce a porsi diverse domande. Senza stare a sottilizzare sulla precisa correttezza empirica della ricostruzione storica, grosso modo, dalla fine del secondo dopoguerra ad oggi e senza considerare un certo squilibrio tra l’attenzione data alla democrazia statunitense e alle democrazie europee, concentriamoci solo su tre domande, forse le più rilevanti.
La prima: esistono effettivamente le due classi in lotta, quella dei manager e un’ampia classe di lavoratori? Soprattutto la Grande Recessione, dal 2008 in poi, e le reazioni dei governi, anche europei, a quella crisi hanno mostrato quello che sostiene Lind, ovvero sia l’indebolimento del sindacati che dei sistemi di welfare con una crescita delle disuguaglianze. Però, la ricerca empirica da molti anni non identifica più vere proprie classi sociali ovvero gruppi in condizioni socioeconomiche simili e una propria percezione di identità di classe. Se ipotizziamo che l’autore usi il termine in senso più lasco, e non consideri la necessità di una ‘coscienza di classe’, come una volta si diceva, rimane che i comportamenti politici e gli atteggiamenti culturali di soggetti con una simile posizione economica sia molto differenziati nelle diverse democrazie europee. E, ad esempio, l’età e solo in parte l’istruzione siano più rilevanti come fattori in grado di spiegare meglio la diversificazione degli atteggiamenti. In breve, almeno in una prospettiva empiricamente attenta, nelle attuali società post-industriali e largamente finanziarizzate – come sottolinea anche Lind – la frammentazione sociale, economica, culturale e politica è talmente accentuata da non consentire di identificare classi, e tanto meno due classi solamente.
La seconda: si può effettivamente trasformare quel conflitto in una coesistenza pacifica e benefica attraverso il pluralismo democratico indicato da Lind. Potrebbe essere sicuramente auspicabile sia l’integrazione ai diversi livelli, sia la condivisione delle decisioni economiche essenziali, sia la pacificazione. La stessa pandemia potrebbe spingere in quella direzione contrattuale e ragionevolmente compromissoria. Ma se avvenisse, accadrebbe sempre in modo parziale e ambiguo. Gli attori intermedi che hanno caratterizzato le democrazie degli anni Sessanta e Settanta peraltro non esenti da critiche e problemi, non possono più risorgere. Senza dire che l’aspetto essenziale di quegli anni non riguardava partiti e sindacati, che pure ne erano i protagonisti, quanto il fatto che si trattava di anni di crescita economica continua e consistente.
La terza: quella di Lind è, alla fine, la ricetta corretta o ve ne sono altre più realisticamente realizzabili? Per rispondere a questa domanda occorre considerare l’errore che Lind si porta appresso in tutta la sua analisi. In breve, la sua proposta è di tipo procedimentale ovvero costruiamo regole e meccanismi decisionali in cui tutti siano coinvolti e avremo le decisioni giuste per tutti. Questo ragionamento ha un assunto implicito che è una tipica fallacia notata da diverse ricerche. Infatti, semplificando, se sono al governo degli operai ovvero dei capitalisti non possiamo dare per scontato che nel primo caso ci saranno politiche a favore degli operai e nel secondo dei capitalisti. La complessità delle attuali democrazie in cui la destra sostiene la crescita del welfare e i ceti meno abbienti e la sinistra appoggia l’impresa industriale confonde tutto il quadro effettivo. Nei tempi di crisi che stiamo vivendo, occorrerebbe ripartire, come sosteneva Machiavelli nei Discorsi, dai valori importanti. Questi, secondo la maggioranza dei democratici, sono la libertà e l’uguaglianza. Di conseguenza, innanzi tutto, occorre mettere a punto politiche che realizzino al meglio quei valori, magari anche facendo attenzione alle modalità per realizzarli meglio, in piena consapevolezza che ci vorranno compromessi e aggiustamenti, ma senza mai perdere di vista gli obiettivi effettivi e senza pensare che l’approvazione di certe regole assicurerà il risultato voluto.
Fatte queste considerazioni, si può concludere che se l’obiettivo di un essai è quello di provocare e indurre a riflettere, Lind con questo lavoro vi è pienamente riuscito. E va bene così.
Articolo pubblicato su Luiss Open il 20 maggio 2021